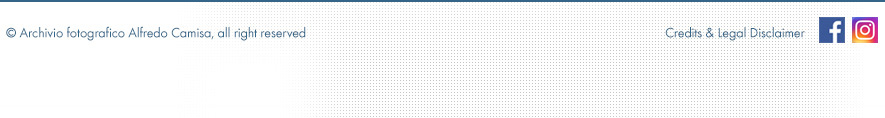![]()
Appunti Archivio Foto Camisa
Note in margine all’epistolario Giacomelli-Camisa (anni 1956/1962)
[…] le lettere possono appartenere a due diverse tipologie: lettere scritte col cuore, che svelano chiaramente il carattere dell’autore; lettere che semplicemente comunicano una notizia, forniscono una informazione. E sono la maggioranza.
Non c’è dubbio che le lettere di Giacomelli, quelle almeno indirizzate a me negli anni ’50, appartengono alle prima tipologia.
E cosa emerge da una anche superficiale lettura di questa corrispondenza? Emerge Giacomelli che per me, per noi, è sempre stato l’unico Giacomelli, il Giacomelli vero. Semplice, spontaneo, umile, sincero, candido, molto naïf, ingenuo e provinciale, se mi concedete il termine, in senso buono.
Cioè un uomo, un giovane, che era intensamente partecipe all’atto fotografico e conscio di aver dei talenti, ma che si sentiva tagliato fuori dai centri più attivi del paese, con le ore libere riempite solo dagli interminabili soliloqui dell’“avvocato”, stimatissimo, venerato quasi, ma un poco troppo in cattedra e noioso.
Così lo ho lasciato all’inizio degli anni ’60, isolato, ormai orfano del suo tutore (scomparso nel 1961), e tutto preso dal pensiero delle mostre, dei concorsi, dei premi, delle giurie, di quel che dicevano gli amici e soprattutto i meno amici.
Questa era l’immagine che io avevo ed ho sempre mantenuto di lui. L’immagine – nettamente positiva – di un uomo dolce, mite, un po’ fuori dai tempi, che cercava amicizia e affetto ma anche consigli o critiche da che gli scriveva, e desiderava mantenere i contatti con il mondo – allora solo limitato all’Italia – della fotografia più impegnata.
[…] Ma non è delle lettere che voglio parlare. Non mi sembra debba essere io a commentare questo epistolario: mi interessa invece sentirlo commentare da altri. E neppure parlare delle fotografie di Giacomelli, sulla cui validità penso che siamo tutti d’accordo.
Mi sembra invece di notevole interesse, almeno per me, parlare dell’uomo Giacomelli, e della sua evoluzione negli anni.
Dicevo pocanzi di come era negli anni ’50: su questo penso che chi lo ha conosciuto non possa che essere d’accordo.
All’inizio degli anni ’60, per motivi contingenti, le nostre strade si sono separate. Io ho chiuso con la fotografia, e ci siamo persi di vista per almeno vent’anni.
Io sono riemerso dal black-out fotografico verso la metà degli anni ’90 ed ho ritrovato, dai suoi atteggiamenti, dalla lettura dei suoi scritti, e soprattutto dagli scritti su di lui, un Giacomelli completamente diverso da quello che avevo lasciato: il letterato, il poeta, l’enigmatico, l’eccentrico (nell’apparenza almeno), lo scontroso e solitario chiuso nel castello incantato, che si concedeva con parsimonia alle visite e alle interviste.
Allora – mi domando – quale era, quale è il Giacomelli vero?
Evoluzione, d’accordo, superamento delle incertezze giovanili, acculturamento della maturità. Può darsi. Me per me è difficile comprendere una tanto drastica evoluzione. Io sono spesso tacciato di dissacrazione, di vilipendio dei miti […].
Non vorrei ora che si dicesse, o che solo si pensasse, che voglio far scendere Mario Giacomelli da quel piedistallo sul quale anche io lo mantengo. Giacomelli era e rimane per me, oltre che un caro amico, un grandissimo fotografo: questo sia ben chiaro. Cerco solo di capire, e cerco la collaborazione di chi lo ha frequentato più continuativamente di me.
[…] Io l’ho visto, ci ho parlato. Ho avuto l’impressione che – forse involontariamente stando al gioco – abbia lui stesso voluto interpretare un personaggio diverso da quello che lui in realtà era, un Giacomelli che in realtà non esisteva. Abbia accettato di costruire intorno a sé una corazza, per difendere il suo animo rimasto semplice, il suo candore, forse le sue ancora esistenti incertezze di fondo. Questa è la mia idea.
[…] Era lui negli anni ’50, quando lo ho conosciuto, quando ci scrivevamo queste lettere e commentavamo senza ipocrisie le sue prime fotografie.
Alfredo Camisa fotografo: professionista mancato o un dilettante impegnato.
Dopo qualche decennio di black-out, sono apparse in questi ultimi anni varie brevi biografie a descrizione e supporto della mia attività fotografica svolta negli anni ’50. Tutte, o quasi, mi definiscono come “fotografo non professionista, ma notevolmente impegnato”. Mi riconosco in questa tipologia? In linea di massima sì. “Amatore”, “dilettante”, “fotografo della domenica” sarebbero termini riduttivi, al limite dello spregio. Come mi vedo? Fotografo di avanguardia per quegli anni. Immagini caratterizzate da toni molto aspri, forti contrasti, assenza di mezzi toni. Soggetti “forti” e situazioni al limite del paradosso, rispetto e compiacimento per la forma, a volte per l’orpello, ma sempre spontaneo e mai artificiale né artificioso. Attratto dallo scavare nel personaggio e descriverlo col contribuito, con la cornice dell’ambiente.
Sono stato presente e produttivo negli anni 1953-1960: la mia presenza attiva coincide con gli anni forse più innovativi e creativamente felici della fotografia italiana.
Di carattere indipendente ed autonomo per quanto riguarda l’impostazione stilistica e creativa, non ho mai ritenuto opportuno legarmi ad alcuno dei circoli amatoriali nei quali si frammentava la fotografia in Italia: venni cooptato nel gruppo “Misa” (1953) e da questo nelle “Bussola” (1956) su spinta dell’avvocato Cavalli – padre padrino della fotografia italiana del dopoguerra – che cercava giovani e nuove linfe vitali per le sue creature la cui ispirazione e attualità davano ormai segno di esaurirsi.
Ho partecipato per vari anni a mostre e concorsi nazionali e internazionali, riportando un notevole numero di premi e riconoscimenti, soprattutto nelle manifestazioni più di avanguardia, cha hanno rappresentato una vera e propria svolta della fotografia italiana: le mostre di Castelfranco Veneto (1955), di Padova (1956), di Salsomaggiore (1956), di Sesto S. Giovanni (1956) in particolare.
Questo genere di presentazione della mia produzione fotografica inizia, nel tempo, a diminuire di interesse e di soddisfazione: a esso gradualmente si sostituisce una attività indirizzata verso mostre personali […], a invito o collettive […] e soprattutto la elaborazione di immagini finalizzate alla pubblicazione […]. Fotografie insomma non come fini a se stesse ma destinate a essere viste da una platea più vasta di quella dei soli addetti ai lavori. Meno “arte” insomma, e più contenuto. Da questa più aggiornata e più professionale posizione nasce la mia collaborazione continuativa con il settimanale «Il Mondo» e il contatto con editori di vari paesi europei […].
Come fonte di ispirazione mi sono sempre sentito attratto dalle immagini dei fotografi realisti americani (da Hine a Walker Evans, a Dorothea Lange e FSA, a Eugene Smith), dai francesi (Cartier Bresson, Brassaï), e, soprattutto, per il magistrale impiego delle tonalità scure, dei neri catramosi e la esaltazione di alcune periferie industriali, dai tedeschi della Subjektive di Otto Steinert.
Sulla base di queste conoscenze e di una attività eccezionalmente intensa, pur in convivenza con un “vero” lavoro […] sono riuscito a produrre diverse sequenze di fotografie di impostazione nuova, abbastanza originali e rappresentative della mia personalità.
[…] la mia foto più nota, pubblicata e premiata? Siesta del 1955. La più “bella”? Nessuna. Quella di maggior successo a mostre, concorsi, ecc.: Siesta nella rimessa (1956). La più sentita e amata da me? Scuola coranica (1956), Elezioni in Sicilia (1955), le immagini notturne e nebbiose di periferia. Quelle foto che – a mio avviso – in un solo colpo d’occhio fanno entrare il lettore nell’atmosfera e nell’ambiente, a volte irreali, nei quali il soggetto era stato trovato, senza forzature, trucchetti, false pose.
Strumenti di lavoro: sincerità, rispetto del soggetto, importanza dell’aspetto compositivo, formale e tonale.
Risultato: il brusco e totale abbandono della fotografia (1961) per un’attività certamente meno creativa e di assai minore soddisfazione interiore, ma che allora garantiva, a differenza della fotografia, pane e companatico per me e la famiglia che intanto s’era andata formando.
Alfredo Camisa fotografo: un dilettante impegnato (ovvero un professionista mancato).
Fotografo “impegnato”, non professionista, attivo negli anni 1953-1960.
Inizio a fotografare nel 1953; invio le mie primissime foto (composizioni) a una rassegna (Castelfranco Veneto) rivelatasi a posteriori notevole importanza nel profondo cambiamento che stava verificandosi nella fotografia italiana. Sorprendentemente mi viene assegnato uno dei tre massimi premi (premio “Ferrania”).
L’entusiasmo e la soddisfazione di questo positivo inizio fanno aumentare il mio interesse ed il mio coinvolgimento nella fotografia: da semplice dilettante occasionale, mi trovo ad essere fotografo “impegnato”.
1953-1955: il mio stile e i miei interessi fotografici si modificano abbastanza rapidamente, passando dalle composizioni iniziali a temi sempre più legati alla figura umana: appartengono a questo periodo la serie Impressioni di Sicilia, La cascina, La falce, La donna del botteghino.
1956: per la mia “produzione” è un anno particolarmente positivo sia dal punto di vista qualitativo che da quello del numero di foto valide scattate. Appaiono la serie delle “bancarelle” di antiquariato, dell’Inverno a Milano, e soprattutto la ampia rassegna delle foto africane (Scuola coranica, Preghiera, La siesta nella rimessa, ecc.) […]. Le mie foto iniziano ad essere (impropriamente?) definite “realiste”: sarebbero in realtà meglio classificabili in un filone di “ritratti d’ambiente”, in un realismo trasfigurato, nel quale l’ironia, il paradosso, il contorno molto ricercato e formale giocano un ruolo determinante.
Gradualmente il mio interesse si sposta dalla partecipazione a mostre e concorsi ad altri sbocchi più diretti e visibili […]. Risale a questo periodo l’inizio della mia collaborazione, poi diventata continuativa, con il prestigioso settimanale politico e letterario «Il Mondo».
Ho sempre cercato di tenermi aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la produzione fotografica straniera: le prime foto rimaste impresse nella mia memoria sono quelle dello Spanish Village di Eugene Smith, e poi Hine, Walker Evans, Dorothea Lange e la FSA, Brassaï e Cartier Bresson, la scuola Subjektive di Otto Steinert. Questi autori certamente hanno influenzato, o almeno ispirato, il mio approccio alla fotografia.
1957-1960: col passare degli anni ho sempre più trascurato l’aspetto “formale” delle mie immagini, conferendo invece maggior risalto all’aspetto tonale e al soggetto “uomo”, con particolare attenzione all’ambientazione e agli stati d’animo quali la solitudine, la stanchezza, la tristezza […]. Considero questo periodo come la fase più valida della mia attività fotografica, quella nella quale mi sento più compiutamente realizzato.
Alla fine del 1960 ho pubblicato, con l’editore LEA, il volume Lo stretto di Messina e le Eolie, e questo è stato il mio canto del cigno. Ho rinunziato alla professione di fotografo, interrompendo bruscamente e completamente l’attività fotografica.
Le foto che considero più significative e rispondenti al mio modo di sentire: Elezioni in Sicilia, Scola coranica, Lutti in Sicilia, Uomo a Gela, Notte di Piedigrotta: pazzarielli, Processione a Siviglia, Sappada, Valentina Cortese.
P.S.: non ho mai preso in considerazione, se non per quanto riguarda la massima cura nella stampa, gli aspetti “tecnici” della fotografia.
Appunto biografico
Ero troppo povero, negli anni del dopoguerra, per permettermi il possesso di una macchina fotografica: padre in campo di prigionia in Egitto, madre in campo di lavoro in Svizzera, studi universitari iniziati grazie a qualche provvidenziale ma modesta borsa di studio. Cercavo di procurarmi un cappotto per l’inverno, e l’unica soluzione fu una coperta dell’esercito americano trasformata in cappotto, con tanto di U.S. ARMY che traspariva sotto la pessima tintura, che mi salvò nei rigidi inverni del 1945 e 1946. In realtà ancora non mi interessavo di fotografia: amavo la Storia dell’Arte grazie a una brava e valida insegnante del Liceo, scoprii da solo il De Chirico metafisico, le tristi periferie di Sironi, le essenziali case toscane di Rosai, e poi Tomea, Campigli e via via gli impressionisti, gli espressionisti tedeschi, Munch.
E venne spontanea l’idea di surrogare la pittura e la mancanza delle indispensabili relative conoscenze tecniche con il più semplice ed abbordabile mezzo di espressione figurativa: la fotografia. Compravo ogni mese una rivista (il mercato editoriale italiano non offriva allora niente di più), acquistai (usato) il Fotolibro della Hoepli, e solo dopo la laurea riuscii a procurarmi, a rate, una Voitglander Vito II.
Ma per fare che foto? Quelle che allora andavano per la maggiore, e si vedevano su «Ferrania» o sulle copertine dell’«Illustrazione del Medico» nella sala di attesa del dottore. Sembravano le uniche che il mezzo fotografico potesse esprimere per fregiarsi del titolo di “arte”: cieli coperti di nuvole (drammatizzate dal filtro arancione), architetture moderne o impianti industriali che si stagliavano sui cieli corruschi, riflessi di architetture nelle pozzanghere, zingari, straccioni e mendicanti visti con occhio folkloristico, scenette di genere senz’anima o ambientazioni stile I Miserabili, preti e suore con sfondi drammatici di chiostri e chiese con atmosfere da Monaca di Monza, nature morte fredde, slavate e asettiche.
Questo, nei miei ricordi, era il panorama e questi erano i modelli della mia iniziazione fotografica. Il tutto stampato presso laboratori esterni, possibilmente su carta mat, spesso “camoscio” e magari con i bordi frastagliati. L’ignoranza del mondo fotografico internazionale era assoluta. Nessun fotografo italiano aveva per me un nome, una fisionomia definita, uno stile personale e “moderno”.
[…] Rimaneva ancora, nella maggior parte dei fotografi “amatori”, la strenua difesa e la conservazione della tipologia preferita: la scenetta di genere, il compiacimento formale fine a se stesso. Solo una minoranza stava prendendo coscienza di quanto potesse offrire il mezzo fotografico, unito a una cultura, a una particolare sensibilità al contenuto, alla struttura dell’immagine, alla scelta ed al dosaggio delle tonalità, a una ricettività a “sentire” i problemi e le istanze sociali.
Anche io cominciai seguendo le tendenze dell’epoca: nuvole, pozzanghere, suore, capanne bianche sul mare, e via dicendo. Ho letto recentemente un bel volume sul fotografo friulano Della Mura, attivo negli anni ‘50: mi ha colpito il fatto che afferma di non conservare nessuna delle sue foto iniziali, ma neppure una lontana memoria di quel che fotografava in quegli anni. Io invece ricordo perfettamente la cronistoria di ogni foto scattata, e ne conservo ancora negativi e copie. Fotografavo, ma non ero soddisfatto di quello che producevo: possibile che non si potesse fare qualcosa di diverso, di più “moderno” e più personale?
Tanto bianco e tanto nero, tanti contrasti in contrapposizione alle ovattate nature morte dell’epoca. Trovai non so come né dove il bando di una Mostra Fotografica, la prima che mai mi fosse capitata nelle mani, e spedii – più per curiosità che per convinzione – alcune foto, scelte fra le poche che avevo. Ignoti, per me, i componenti della Giuria (P. Monti, F. Roiter, G. Comisso, G. Mazzotti, G. Oliva), ignoto il luogo (Castelfranco Veneto), ignota l’esistenza di eventuali “tendenze”, gradimenti, eccetera. E dopo qualche settimana ecco un telegramma del tutto inatteso: «Assegnatole premio Ferrania Mostra Fotografica Castrelfranco Veneto.Congratulazioni - Gino Oliva Segretario». E la motivazione, giunta successivamente, diceva: «All’autore il cui complesso di opere sia la nobilitazione di un genere fotografico». Era il primo riconoscimento “ufficiale” per le mie foto. Il mio modo di interpretare certi soggetti e certi ambienti poteva rivestire qualche interesse, almeno di carattere fotografico.
Non andai all’inaugurazione della Mostra (non sapevo che la tradizione lo prevedeva). Nessuno mi vide e mi conobbe, rimasi per tutti l’oggetto misterioso, e si insinuò persino che io non esistessi, e che le mie foto fossero in realtà un trucco di Monti – la personalità di maggior peso nella Giuria – per intorbidare le acque, già smosse, del nostro provincialismo fotografico e culturale.
In realtà quella mostra, per le scelte fatte in sede di selezione, per l’originalità della composizione della sua giuria (non solo fotografi, ma anche prestigiosi esponenti del mondo della cultura e dell’arte) fu un primo seme di quel radicale giro di boa che la fotografia italiana fece nell’arco di pochi anni. Anche il bel catalogo, per la prima volta in veste di volumetto (Fotografia italiana 1955) fornì un contributo non indifferente alla conoscenza della mostra e dei suoi esiti e portò alla ribalta le immagini e i nomi, ancora pressoché sconosciuti, di Branzi, di Camisa, di Giacomelli, di Ferri, di Berengo Gardin, di Möder.
Altre Mostre e concorsi di notevole importanza e di rottura seguirono in tempi relativamente brevi, intercalate ovviamente dalla pletora dei saloni tradizionali, ma staccandosi nettamente da questi per modernità, varietà di contenuti, di soggetti, di toni, di taglio e di composizione formale.
Sotto i colpi delle fotografie di una nuova generazione che mal sopportava la pesante cappa della fotografia tradizionale e il monopolio culturale dei baroni della fotografia, vennero allo scoperto il Monti dell’Angelo a Venezia, il Roiter di Venise à fleur d’eau, il Giacomelli dei primi paesaggi marchigiani e di Vita d’ospizio, e la fotografia italiana cominciò a cambiare.
Anche io, come gli altri miei amici, allargai i miei obiettivi verso orizzonti più vasti. Rimase nelle immagini il rispetto delle geometrie e della composizione rigorosa, la preferenza verso le tonalità contrastate, ma iniziò – timidamente – a comparire la figura umana che apparve, da principio, quasi come supporto alla grafica, e poi sempre più rilevante, sino a essere il vero e unico soggetto del fotogramma. Ecco nascere, emblematiche di quegli anni, accanto alle mie foto più note (La Donna del botteghino, Uomini della Confraternita, Lutti in Sicilia, le varie Bancarelle), le immagini di Monti, la Donna a Matera di Branzi, i ritratti La madre e Anna di Giacomelli.
Si può affermare che, superata questa fase, da quel momento la fotografia dei più avanzati autori italiani non fu più la stessa: l’uomo, la figura, la figura “ambientata” soprattutto presero il sopravvento divenendo il soggetto principale delle immagini dei fotografi italiani.
Raccolta di appunti sparsi su «Il Mondo»
Per quanto riguarda le foto, Pannunzio sceglieva, impaginava, titolava a sua completa discrezione e arbitrio.
Le fotografie erano per lui qualcosa di strumentale per riempire degli spazi tipografici vuoti. Certo che doveva essere non un’area grigia indeterminata, ma un qualcosa di intelligente, di ironico, di sottilmente attinente alle tematiche di uno degli articoli che circondavano l’immagine. Ma sempre “contorno”, mai agli onori di “portata” principale. Strumento di un discorso visivo generale che solo lui sapeva concepire e “vedere”.
Un mondo da smitizzare
Era un piacere, per molti di noi, vedere le nostre foto pubblicate su «Il Mondo». Non per ragioni economiche: la Redazione pagava poco, perennemente in ritardo, perdeva le fatture, sbagliava i conteggi delle foto “trattenute”. Ma perché era un giornale intelligente, era la coscienza critica dell’intellighenzia illuminata italiana, era ben impaginato, si avvaleva di firme di prestigio, era anticlericale, di sinistra, faceva cultura.
Ma non fu, per me almeno, quella scuola di professionalità, quella palestra di alta fotografia che poi venne posta su un piedistallo e trasformata in cult venerato e intangibile. Ho visto tante mie foto pubblicate (forse un centinaio): alcune delle mie migliori, ma anche tante fra le più banali, riesumate nei cassetti o scattate “su misura” per i gusti del direttore Pannunzio. Le chiamavamo, in tono vagamente allusivo e ironico, “foto per Il Mondo”, bozzetti di buon livello, intrisi di satira del provincialismo, di immagini del provincialismo del Sud, di ironia surrettizia, di presa in giro dei Potenti, dei Baroni, dei Tromboni.
Insomma, un divertimento di prestigio, un fiore all’occhiello e una illusione, vista la regolarità della pubblicazione delle foto, di essere non solo dei dilettanti, ma (quasi) dei fotografi di professione.
L’esperienza de «Il Mondo»
Se non il primo, sono stato certamente uno fra i primissimi fotografi allora dilettanti – o semidilettanti – a inviare e pubblicare fotografie sul “mitico” «Mondo».
Nel breve periodo di collaborazione e di vita del periodico ricordo pubblicate circa cento foto, prima anonime e successivamente con la firma dell’autore, diverse delle quali in prima pagina. E molte, già acquistate, sono rimaste, inedite, negli armadi della redazione.
Ma, a differenza di vari amici e colleghi, non considero a posteriori, ancora oggi, questa collaborazione come esaltante, formativa pietra miliare della mia (mancata) carriera fotografica.
Sfatare un mito
«Il Mondo» non ha impegnato, ha usato i fotografi anche tiranneggiandoli (pagava poco e male e non metteva il nome dell’autore).
[…] Si voleva una corsa alla copiatura ed alla reiterazione dei temi, che lascia un poco perplessi.
Ciò non significa che «Il Mondo» non abbia segnato un’epoca, che non abbia rappresentato un’esperienza divertente, di soddisfazione, ma per me questa esperienza certamente non è stata “formativa”.
È stato uno dei pochi sbocchi di livello culturale per una generazione di fotografi che era a metà del guado.
«Il Mondo» compensò, con scenario di livello superiore, potremmo dire semiprofessionale, l’abbandono delle mostre, che erano state – fino a quel momento – l’unico sbocco per i fotografi dilettanti ma impegnati. Le foto pubblicate ci facevano sentire “alla pari” – almeno come livello qualitativo globale – dei più quotati professionisti.
Progetto per un Alfabeto Urbano
“Progetto”: perché “progetto”? anzitutto perché è un lavoro iniziato e mai portato a termine. Ma dove la trovo, in Italia, una lettera K bella e ben ambientata? Dovrei fare un viaggio in Germania solo per questo? Meno male che, per la X, mi ha salvato Darix con il suo Circo… a parte queste divagazioni, se dovessi riprendere oggi a fotografare probabilmente ricomincerei proprio da qui.
Anche se si tratta di un tema poco impegnativo, quasi di un giuoco, nel quale l’uomo – se c’è – è solo un pretesto, un grafismo, una presenza quasi casuale, certamente utile all’effetto finale, ma mai determinante.
Una presenza discreta, marginale, occasionale, non un “soggetto” dell’immagine, ma solo un elemento “di passaggio” (che infatti appare quasi sempre mosso, sfuocato, comunque difficilmente “leggibile”), che contribuisce a bilanciare e movimentare l’immagine, ma mai sino al punto di divenirne protagonista, di rappresentarne l’epicentro.
Fatta questa premessa, ci si può anche domandare il perché della scelta di questo tema […].
Essenzialmente l’attrazione per le periferie, per lo “squallore” (in senso pittorico almeno) a esse collegato, al senso di desolazione, di freddo, di tristezza che emanano, per quell’alone di “vecchio” che portano con sé. L’argomento mi affascinava (mi “intrigava” si direbbe oggi) e lo svolgimento del tema mi sembrava degno di attenzione. Retaggio anche di giovanili amori per i dipinti di Sironi, di Rosai, di Carrà.
La difficoltà non è – o meglio allora non era – nel trovare il soggetto “giusto”: bastava “battere” la periferia e avere un poco di pazienza.
Il vero problema in una serie “chiusa” di almeno 25 immagini, che dovevano convivere strettamente, era nell’evitare di essere ripetitivi, pur mantenendo un’atmosfera di fondo uniforme […], nel produrre un notevole numero di immagini il più possibile omogenee e personalizzate, restando però quanto più possibile diverse nell’ambientazione, tonalità, forma, stile, ecc.
Un mondo di questo tipo oggi è praticamente scomparso, tutto è diverso, più standardizzato, prefabbricato, omogeneizzato: si è perduta l’“insegna” casalinga ed artigianale: abbiamo in compenso la scritta murale, si passa dall’arcaico al grafismo, che ha il suo fascino, i suoi estimatori, anche il suo prezzo di mercato e pure i suoi fotografi.
Ho scoperto (confesso da poco) che Walker Evans ha scattato foto di questo contenuto, nel suo periodo di “fotografia frontale”, dieci anni prima di me: non lo sapevo, le ho guardate e devo dire che la mia ammirazione per lui, già grande, e la mia identificazione con il suo mondo, è ulteriormente aumentata. Non so se queste mie foto sono belle o sono brutte, se sono valide o meno da un punto di vista estetico. So solo che oggi le ho vedute con piacere e con affetto, sono più che soddisfatto di averle tenute a battesimo e di poterle ora mostrare.
[…] E, dopo averle vedute con l’occhio del critico, dopo aver visto cose analoghe di Branzi, di Giacomelli, di Berengo Gardin presentate e premiate a Mostre e Concorsi di elevato standard qualitativo, mi chiedo come si possa averci contrassegnati con l’etichetta (ormai quasi indelebile dopo cinquant’anni di lavaggi) di fotografi realisti, e poi addirittura neorealisti.
A ben rifletterci, la definizione più appropriata di un certo tipo di fotografia, nuova, fresca e innovativa emersa e affermatasi in Italia in quegli anni (che l’amico Migliori ha recentemente ricordato come “lo splendido periodo degli anni ‘50”) è quella – elementare e semplicissima – coniata e adottata da Giuseppe Turroni: nuova fotografia italiana.
Alfabeto Urbano
Alfabeto Urbano è stato un hobby dentro l’hobby, di carattere “trasversale” come si dice ora in politica, che mi ha accompagnato per tutto il mio percorso fotografico, senza impegnarmi eccessivamente, ma mantenendomi viva la memoria della cose che ho amato da sempre; le periferie urbane, gli interni desolati, le vecchie insegne, i mestieri in estinzione. Se avessi proseguito a fotografare, avrei senz’altro dato ampio spazio alla cosiddetta “archeologia industriale”.
Fotografie a teatro (Dietro le quinte)
Questa parentesi apparentemente anomala, poco “allineata” con il resto della mia produzione fotografica, è racchiusa in un arco di tempo relativamente breve.
Essa rappresenta un diversivo “parallelo”, nato per la curiosità e l’attrazione che avevo non tanto per la rappresentazione teatrale in sé, ma per quanto essa poteva nascondere, di vero e di artificioso, dietro le sue ribalte. Un mondo per me sconosciuto e misterioso, ma che proprio per questo mi incuriosiva e mi affascinava.
Le foto che riguardano questo tema non sono per me fotografie di teatro, ma piuttosto fotografie a teatro, o meglio dietro al teatro.
Le riprese di scena vere e proprie non erano per me di alcun interesse: l’atmosfera, la parte creativa che le coinvolgeva non sarebbe comunque appartenuta a me: era creazione del regista, dello sceneggiatore, di chi operava sulle luci, dell’autore.
Le foto di scena possono risultare belle, mediocri o brutte – secondo me – a seconda che le scene e la regia siano belle, mediocri o brutte. Non esprimono la personalità del fotografo: vivono di luce riflessa, nascono dalla creatività del regista, dello sceneggiatore, di chi inventa le luci e gli scenari.
Gli attori a loro volta recitano un copione, incollato posticcio sui loro veri sentimenti.
I ritratti a teatro avrebbero potuto essere un argomento di maggiore interesse: essi offrono al fotografo più ampi margini di intervento e di creatività. Per me erano però ancora poco spontanei, non sufficientemente “veri”. Un genere artificiale, non rispondente alla mia sensibilità, al mio concetto di fotografia, volto verso l’immagine “rubata” piuttosto che verso la foto “posata”.
Quel che accade dietro le quinte rappresentava invece per me l’aspetto più spontaneo, più sincero, più umano. Ancora però immerso in quell’atmosfera irreale, di sogno, che mi attraeva e mi ammaliava. Dietro le quinte c’è un’altra realtà, tutta vera, da scoprire e mettere a nudo, una realtà a volte resa ancora più grottesca e artificiosa dagli anacronistici costumi, dai cosmetici e dai trucchi. Qui gli attori, i figuranti, le comparse, mostrano il loro vero volto: un volto spesso triste, stanco, spossato. È in questo mondo che ci si immerge in quello spazio temporale in cui l’attore non è più personaggio, ma è solo se stesso.
Immagini che hanno vita propria, che prescindono dallo spettacolo, che vorrebbero scavare nell’intimo dell’attore, non del personaggio. Che vorrebbero trovare l’aspetto a volte ironico o paradossale della situazione, o il lato più umano: la tensione, la fatica, la stanchezza, forse un senso di solitudine, a volte addirittura la noia. Cercando però di evitare l’aneddoto o il banale.
C’è dietro le quinte un’atmosfera impalpabile, spesso irreale e sempre molto particolare […].
Un’atmosfera che per tanti aspetti rispondeva al fascino, all’attrazione – per me assai forte in quegli anni – della available light, e della fotografia ad alta grana, e alla conseguente atmosfera irreale che – adeguatamente impiegate – potevano creare enfatizzando quel contenuto di tristezza e solitudine che già il soggetto di per sé conteneva.
Questo fu l’approccio col quale per due o tre stagioni del Piccolo Teatro di Milano feci la serie di foto sull’argomento. Che, essendo “fuori” del gusto dell’epoca (che ancora non aveva assimilato le immagini a grossa grana, i fortissimi contrasti, il moltissimo nero) non furono praticamente mai né esposte né presentate. Piacquero però ai pochi – ma qualificati – “addetti ai lavori” che allora le videro.
Non considero questa incursione nel mondo del teatro né un avanzamento né un arretramento rispetto alle mie altre tematiche dell’epoca. Solo un corpus a se stante, con caratteristiche di stile e contenuto diverse. Una “divagazione” che mi ha reso pochi onori (del resto non cercati), ma molte soddisfazioni di carattere personale.
La tristezza, la stanchezza
Nell’ormai lontano 1961 un Editore tedesco mi scriveva: «Pensiamo che sarebbe forse il caso di dedicare un volume di questa pubblicazione straordinariamente interessante alla Sua opera. Ci sono piaciute soprattutto le Sue foto dei bambini, e pensiamo di pubblicare le Sue fotografie sotto il titolo – provvisorio – Bambini. In questo modo Lei apparirebbe in maniera molto rappresentativa (e verrebbe reso noto) davanti a un pubblico internazionale. Se dovesse essere d’accordo con la nostra proposta, La preghiamo di volerci inviare con cortese sollecitudine una scelta piuttosto voluminosa delle Sue migliori fotografie di bambini, ragazzi e ragazze, per poter prenderne visione e per poter selezionare le più adatte»
Inviai un centinaio di mie foto, scelte tra quelle che mi sembravano più valide ed attinenti al tema.
Alcune settimane dopo mi giunse questa desolante risposta: «Abbiamo ricevuto la Sua selezione di fotografie, che abbiamo studiato con grande interesse e piacere. Le sue foto sono eccellenti: con grande dispiacere dobbiamo però dirle che ciò non è sufficiente per fare un libro sui bambini che deve anche essere venduto. Secondo noi il tema è stato visto da Lei da un unico punto di vista, e cioè Lei mostra esclusivamente foto di bambini molto seri, che quasi sembrano vecchi. Ciò che manca sono le fotografie della allegria e della spensieratezza, caratteristiche che noi dei Paesi del Nord ammiriamo particolarmente nei bambini italiani».
Al di là del folklore immaginario dei turisti, non si può dimenticare che in quegli anni non erano ancora rimarginate le ferite della guerra, del passaggio al fronte, della fame. È vero: i bambini del dopoguerra, i bambini del Sud, i niños de rua erano tristi, gli operai, i facchini, i taxisti erano tristi, gli attori durante e dopo le loro spesso estenuanti prove e performances erano stanchi e tristi.
E molte delle figure che compaiono nelle mie foto sono tristi, sono stanche. È triste il facchino della stazione, è triste il taxista di Broadway, il clown del circo, ha lo sguardo triste persino il pazzariello di Piedigrotta. Sono stanchi il portatore di croce spagnolo, l’attrice Valentina Cortese, le comparse nei camerini dei teatri. Perché? Forse il mio “pessimismo della ragione”? o più semplicemente forse l’obiettivo fotografico, nella sua spietatezza oggettiva, scava nelle pieghe dei volti e dei corpi, e registra ciò che l’occhio dell’uomo non vede, o non vuole vedere.
Aveva ragione Pavese: lavorare stanca.
Molti dei personaggi delle mie fotografie sono stanchi, tristi, desolati, con il volto che esprime scarse speranze per il futuro. Ma non era forse questa l’immagine più vera dell’Italia del dopoguerra? Anche senza le posticce etichette di “realismo”, di “sbracata retorica del realismo”, l’occhio del fotografo impegnato e sensibile la vedeva proprio così.
Documentazione:
Starnberg, 12 agosto 1961
Gentilissimo Dottore!
[…] Pensiamo che sarebbe forse il caso di dedicare un volume di questa pubblicazione straordinariamente interessante alla Sua opera. Ci sono piaciute soprattutto le Sue foto dei bambini, e pensiamo di pubblicare le Sue fotografie sotto il titolo – provvisorio – Bambini. In questo modo Lei apparirebbe in maniera molto rappresentativa (e verrebbe reso noto) davanti ad un pubblico internazionale.
Se dovesse essere d’accordo con la nostra proposta, La preghiamo di volerci inviare con cortese sollecitudine una scelta piuttosto voluminosa delle Sue migliori fotografie di bambini, ragazze e ragazzi, per poter prenderne visione e per poter selezionare le più adatte.
[…] Infine vorremmo pregarla di fornire le singole fotografie con esaurienti didascalie. Sarà nostra premura farle conoscere la nostra decisione definitiva non appena riceveremo il materiale di cui sopra.
Josef Keller Verlag
Milano, 26 agosto 1961
Vi ringrazio per la proposta per un libro sui “Bambini” nella serie “selezione fotografica” che avete in programma di iniziare. Posso mettere a Vostra disposizione un buon numero di fotografie su questo argomento; poiché molte delle foto devono essere stampate, potrei effettuare l’invio di tale materiale circa entro il giorno venti del prossimo settembre. Per quanto riguarda le notizie biografiche e i dati sulle singole foto, provvederò a farvele pervenire dopo che avrete preso visione del materiale fotografico.
[…]
Alfredo Camisa
Starnberg, 7 novembre 1961
Dear Mr. Camisa,
This is to acknowledge receipt of your selection of photos which we have studied with great interest and pleasure. Your pictures are excellent, but much to our regret it is not sufficient to make a book about children which will be bought, too. In our opinion the theme is seen by you from one side only, i.e. that you bring without exception photos of very serious and “old-looking” children. What we are missing are photos full of cheerfulness and carelessness, characteristics which we northerns especially admire at the Italian child.
Perhaps you have still got some photos of this kind in your archives, or otherwise would it be possible for you to make some new pictures in the meantime?
Looking forward to hearing from you, we remain,
Yours very truly,
Josef Keller Verlag
Milano, 7 gennaio 1962
Dear Sirs,
[…] I regret that the pictures have not been considered sufficient to make a book; unfortunately at this moment my work does not leave free time for a “campaign” of pictures expressly on this subject.
The only thing I may suggest you, if you are interested in the argument, is to integrate my pictures with others of another photographer, very close friend of mine, who probably has in his archives some photos of children.
I hope hearing something from you, if you agree with this idea; in this case I would like to know how many pictures of “cheerful and careless children” would you need to integrate the selection you have done with mines. If you will not agree with this suggestion, I hope you will be so kind to let me have back my pictures, properly packed.
Looking forward to hearing something from you, I remain
Very truly yours
Alfredo Camisa
Stralcio da una pagina di un diario mai completata
(Ora in Alfredo Camisa. Autore dell’anno, Collana monografica FIAF, FIAF, Torino 2007, p. 68)
Non sta a me giudicare se queste mie immagini sono valide o meno, se sono realiste o neorealiste, o lirico realiste.
Vorrei solo sapere se in esse si “sentono” il Sud, la Sicilia, quelli veri, quelli non ancora contaminati dai teleromanzi, della televisione, dai caroselli di Mike e di Baudo. Quella di allora, dei pupari veri, dei cantastorie (sia pure con il megafono), degli zolfatari (si pure con i Rayban) con i polmoni ancora devastati dall’anidride solforosa, dell’acqua portata in certi paesi con un carro trainato dai buoi, oppure, in altre sequenze altrove, se traspare la solitudine del taxista in attesa a Broadway oppure lo squallore della desolata stazione ferroviaria nella notte, la noia degli attori fuori scena, la fierezza – gratuita – dei nullafacenti tuareg, la spavalderia e il protagonismo di poveri derelitti che della vita protagonisti non saranno mai, se non della propria misera condizione.
I personaggi delle mie immagini sono assai frequentemente poveri, o si atteggiano proprio a personaggi protagonisti. Sembra quasi che recitino una parte scritta per altri. Poveri ma fieri, orgogliosi, quasi seduti su un trono, circondati da un’aureola, nobilitati in questa situazione da un alone di orgoglio e durezza.
Appunti su Siesta
(Ora in I. Zannier, Alfredo Camisa. Dal colore al bianconero, in «Semestrale dell’Archivio Fotografico Toscano», XXI, Dicembre 2005, 42, p. 16)
Sarà un caso, sarà un pedaggio (anticipato) che dovevo pagare alla notorietà, fatto si è che diverse delle mie foto più conosciute o pubblicate, prima di vedere la luce si sono lasciate alle spalle vicissitudini o storie abbastanza singolari.
[…] Dirò ora di Siesta […] presentata al Primo Concorso Nazionale Premio Città di Padova dello stesso 1956 e premiata con il primo premio e Coppa della Presidenza del Consiglio.
La foto è poi stata pubblicata, in Italia e all’estero, su numerosi quotidiani, riviste e volumi, e ha avuto una larga notorietà sia per le sue caratteristiche intrinseche (spontaneità, struttura, composizione, toni, ecc.) che per il soggetto e la particolare tonalità. Stampata in bianco e nero “bruciato”, esasperato, rappresentava l’archetipo dell’idea del sole accecante e delle pigre atmosfere del Sud.
Utilizzata quindi a piene mani, a partire dal serio e compassato quotidiano londinese «Observer» sino alla confezione e alla pubblicità di lenzuola tedesche sul settimanale femminile «Constanze».
Ma come è nata?
Mi trovavo all’Isola d’Ischia, sposato da poco più di un anno ma scapolo da un paio di giorni per la recente nascita del primogenito. Soggiorno e vitto in Hotel rimborsati, a compenso di un premio fotografico, da “smaltire” entro il mese in corso.
Girovagavo nel centro del paese, alla ricerca di qualche soggetto da affrontare con la macchina fotografica quando sento, dapprima in lontananza poi sempre più ravvicinato, il fragore di una banda. I suonatori arrivano, disposti su due file lungo gli opposti bordi del vialone, puntando sulla piazzetta nella quale mi trovo: devo arretrare e spostarmi in un cortiletto laterale.
Qui, protetto dall’ombra di un porticato, riposa tranquillamente un giovane vetturino, sdraiato sulla sua carrozza: immobile, ben composto, in atteggiamento naturale e spontaneo, pronto per essere fotografato. Insomma, vorrei dire che la foto era lì che aspettava me. Il tutto immerso in una tenue, delicata, luce fiabesca; il soggetto sembrava galleggiare in una ovattata luce verde azzurrina che conferiva all’insieme un’atmosfera irreale. Bastava solo schiacciare un bottone, fare click, e i giochi erano fatti. Un’opportunità irripetibile per luce, soggetto, geometria dell’insieme. Caricai – o meglio tentai di caricare – la mia Leica M3, ma il bottone non andava più giù, la pellicola non avanzava. La macchina sembrava bloccata.
Il soggetto – ignaro dei miei travagli – continuava a dormire; in una posizione di equilibrio (o di equilibrismo?) così instabile da non poter prolungarsi per molto.
D’altra parte, in una situazione così precaria mi sembrava non effettuabile la ricarica di una nuova pellicola.
Afferrai l’altra macchina (una Rolleiflex) e scattai in rapida successione due fotogrammi “di emergenza”, senza possibilità di regolare sensibilità della pellicola, distanza, tempo di posa, diaframma. Dopo il secondo scatto pure la Rollei era in tilt (anche qui fine del film), mentre il vetturino iniziava a dare inequivocabili segnali di risveglio.
Nel buio della camera dell’albergo trovai la conferma di quanto accaduto: sulla Leica la pellicola (a colori) era terminata, e quindi bloccata sulla metà dell’ultimo fotogramma. Che non poteva ulteriormente avanzare, restando di conseguenza bloccato (ma stranamente anche impressionato) sino a circa metà. Peccato. Sarebbe stata senz’altro una buona foto: la luce era veramente meravigliosa, e la composizione fuori dall’usuale, estremamente ben strutturata e lontana dai deleteri confini del tanto aborrito quanto diffuso macchiettiamo dell’epoca.
[…] Presi comunque atto di quanto successo, riposi la diapositiva in Archivio (ove rimase – ignorata – per ben 47 anni) e coltivai il mito della Siesta in bianco e nero sfornatami dalla Rollei.
Solo qualche mese fa, in una revisione critica delle mie foto più note, ho realizzato che la tanto famosa Siesta era in realtà stata concepita a colori, e che ne esisteva una versione, sia pure un po’ monca, assolutamente inedita.
Nel frattempo la versione “di ripiego”, in rigoroso coatto bianco e nero, ha fatto varie volte il giro del mondo.
Siesta: ovvero Dalle lenzuola all’Observer
Nata per caso, per un fotogramma a colori rimasto incastrato a metà nella M3. Provvidenzialmente supplì la Rollei, a tutt’altre foto destinata, e nacque così la mia foto certamente più nota e più pubblicata. Specie all’estero, perché faceva molto Italia, folklore meridionale, pigrizia e indolenza mediterranea: ma con bonarietà e un po’ di simpatia.
Ma quando qualcuno (tanti, devo dire) domanda “come” è stata fatta, se è veramente spontanea o, piuttosto, “costruita”, perché è così inquadrata, perché non ci sono mezzi toni, perché sono trascurati i dettagli, perché le ruote sono tagliate a metà, come si fa a spiegare perché?
Semplicemente perché, come Elezioni in Sicilia, nasce da una serie di circostanze fortunate, dall’“attimo fuggente” di Cartier-Bresson, dal fatto che il fotografo era nel posto giusto al momento giusto, solo in attesa dell’evento che doveva verificarsi su quello scenario naturale già predisposto, in attesa di una preda che non poteva passare che di lì. O, più semplicemente, solo dalla fortuna?
Elezioni in Sicilia
(Ora in Alfredo Camisa. Autore dell’anno, Collana monografica FIAF, FIAF, Torino 2007, p. 48)
Penso che il pregio principale di questa foto sia il fatto di non essersi trasformata in “reperto archeologico”, ma di aver mantenuto intatto il suo significato, il suo valore a cinquant’anni dal suo scatto (maggio 1955).
Quale valore? Per me c’è tutto quello in cui io (fotograficamente) credevo: l’impegno sociale diluito dall’ironia, l’atmosfera e la luce del Sud, il rispetto delle geometrie, l’anticipazione di una forma espressiva (la foto è del 1955 e Klein non sapevamo ancora chi fosse) allora qui sconosciuta, la esasperazione dei contrasti, il dinamismo eretico per quei tempi ma qui usato in modo funzionale, e via dicendo.
L’abilità del fotografo? Essenzialmente la sensibilità a certe problematiche, e l’essere al posto giusto nel momento giusto.
Cantastorie a Leonforte
(San Donato Milanese, aprile 2005)
Egregio Signor Vasta,
ecco esaudita la Sua richiesta, anche più velocemente delle mie previsioni, se le Poste non faranno qualche brutto scherzo.
Spero che la documentazione allegata risponda a quanto da Lei desiderato.
Leonforte? Rimane per me uno scenario simbolo del passato remoto. Forse una sosta per un caffè, poi la improvvisa, inattesa visione di questo ondeggiare di coppole, di spettatori esclusivamente maschili, in uno scenario ai miei occhi quasi teatrale, da film di Pietro Germi («Massaro Turi Passalacqua, so che ci siete. Venite fuori») o da Scanno di Henry Cartier Bresson, e l’incredibile comparsa di un cantastorie. Uno spettacolo anacronistico, già allora indietro di cinquant’anni, ma reso attuale dalla partecipazione seriosa, quasi corale, degli spettatori presenti (e non erano pochi), in quella piazza così siciliana.
Il tempo di scattare un rullino, e via. Leonforte, il perché di quella sosta ispirata da qualche occulta Divinità (laica, naturalmente...) della fotografia, cancellato dalla memoria. Ma addirittura non dalla storia della Fotografia Italiana. Il nome della vostra fotogenica cittadina ed il “rito” cui avevo casualmente e fuggevolmente assistito hanno fatto il giro d’Italia per un paio d’anni nella Mostra e nel volume Gli anni del Neorealismo. Tendenze della Fotografia Italiana, Ed. FIAF (2002).
[…] Ma le due foto di Leonforte erano già comparse su «Il Mondo» di Pannunzio e su vari libri, riviste e giornali fotografici e non. Si vedano ad esempio la locandina della Mostra di Pistoia e la critica di G. Calvenzi pubblicata da «Lo Specchio» (supplemento settimanale de «La Stampa» di Torino) entrambe qui allegate.
Cosa posso aggiungere, a concludere? Che certe immagini possono avere un valore assoluto per i loro contenuti pieni di significato e di pathos, e che non perdono di attualità e di valore anche cinquant’anni dopo di essere state concepite.
Pensieri in libertà sulle mie foto
Nei soggetti (personaggi) delle mie foto c’è spesso un fondo ironico. […] Ma ho sempre cercato – almeno nelle intenzioni (o nei limiti delle mie capacità) – di andare al di là di tutto questo cercando poi istintivamente di affiancare all’ironia un qualche cosa di maggior “spessore” che le facesse da “contrappeso”: l’atmosfera di un ambiente, la solitudine che si legge in uno sguardo o, invece – all’opposto – una forte componente compositiva o tonale.
E anche per questa posizione, per questo “filtro” attraverso il quale cercavo di vedere e di far vedere la realtà, e che spero non sia rimasto solo al livello soggettivo o di intenzione, rigetto l’etichetta – non offensiva, certo, ma secondo me impropria e limitativa – di “realismo” (o di un non meglio definito “neo-realismo”), attribuita alla mia produzione fotografica.
I personaggi nelle foto di P.G. Branzi e A. Camisa
Una delle più evidenti diversità tra i due Autori sta nell’atteggiamento, nel comportamento dei soggetti rappresentati nelle foto. I miei “personaggi” sono in genere più “tragici” (sguardi duri, o rassegnati, o spenti), quelli di Branzi più ironici, goliardici, “furbetti”.
Per il resto, molte delle foto di entrambi si compiacciono del non reale contorno, degli “orpelli”, di quello che, dal di fuori, fornisce un elemento in più per la caratterizzazione del personaggio (che già di suo è spesso inconsueto).
[…] Per quanto riguarda me e le mie immagini, in fondo mi è sempre piaciuta quella che potrei definire come la irrealtà della realtà, colta per caso o creata ad arte, la situazione paradossale, l’ironia portata all’estremo. Ma tutto immerso in un contesto reale, vero, non posticcio.
Ma, per favore, non chiamatemi “fotografo realista” o, peggio ancora, “neorealista”.
Una “stagione da non dimenticare” (in occasione della mostra Gli anni del Misa)
[…] Cosa succedeva negli anni ’50?
Si usciva da un periodo devastante: il fascismo, la guerra, la fame, i mille problemi e bisogni culturali, il black-out culturale in tutti i campi, dalla letteratura alla fotografia.
Per rimanere nel nostro campo di interessi, in fotografia avevano resistito al tornado alcuni mostri sacri: i supertradizionalisti (Peretti Griva), i pittorialisti (Moncalvo, Stefani, ecc.), faceva qualche timida comparsa la avanguardia di allora (Cavalli, Vender, ecc.).
Ma sorgevano soprattutto attività più aggiornate e più in linea con la fotografia che ci stava arrivando da altri paesi e che ancora ignoravamo: iniziava la stagione dei circoli o dei gruppi ad alti livelli: “La Gondola” a Venezia, “L’Unione fotografica” a Milano, “La Bussola” a Senigallia. Ma incalzavano anche tanti giovani (o meno giovani) ai quali anche questo mondo fotografico stava un po’ stretto: da Monti a Roiter, a Branzi, Giacomelli, Migliori, al sottoscritto.
Avevamo trovato, come avanguardie fotografiche e bagaglio culturale, il Manifesto della “Bussola” (1947) zeppo di citazioni crociane, i muri e le palline da golf di Cavalli, le atmosfere da film francese di Leiss (e perché no, anche di Donzelli). Avevamo la certezza che dalla fotografia si potesse ottenere molto di più. Di più creativo, di più autonomo e “specifico”, di più al passo con i tempi, di più legato alla realtà vera dei tempi, di più realistico e meno di effetto cinematografico.
Impegnarsi sul soggetto piuttosto che giocare con le luci.
Facemmo la nostra gavetta con la forma, passaggio obbligato ma fondamentale per qualsiasi sviluppo futuro. Composizioni fredde, ma già all’inizio lontane da quelle dei maestri dell’epoca. Non i muri grigiolini di Cavalli, ma i bianchi abbacinati, i neri intensissimi, le composizioni astratte. In alcuni casi creazioni originali, in altri forse inconsapevolmente ispirate dalla scuola espressionistica-grafica tedesca di Otto Steinert.
[…] Con questo bagaglio formale acquisito, da queste premesse al realismo il passo – per molti di noi – fu relativamente assai breve.
Il “clima” era stimolante dal punto di vista culturale (arrivavano le prime foto di Dorothea Lange, di Eugene Smith, i mossi-sfuocati di Klein), fertile per la altissima produzione di elevata qualità, novità stilistica e spessore culturale. Mefitico invece dal punto di vista dei rapporti umani. […] Rare le amicizie sincere.
Che fotografie si facevano? Si passò dalle scenette di genere, dal “macchiettismo” imperante, dagli effetti di luce, alla fotografia più impegnata, a un realismo reale […] attraversato da una vena di ironia, di malinconia, che coinvolgeva tutti gli autori più rappresentativi (Branzi, Gardin, Casiraghi, Colombo, il sottoscritto), al realismo più introspettivo e lirico dei pretini o dell’ospizio di Giacomelli, per arrivare al quasi reportage della Niccolai o di De Biasi o alle reinterpretazioni tonali del reale tipiche della fotografia di Paolo Monti.
Una “stagione”, insomma, densa di cambiamenti, di novità stilistiche, di risultati concreti, ma anche di polemiche a volte feroci.
In questo clima nacquero – ma soprattutto morirono – vari dei gruppi fotografici più importanti. Primo fra tutti “La Bussola” (1947), abbandonata dai più innovativi dei suoi aderenti, e poi “Il Misa”, creatura asfittica e artificiosa voluta da Cavalli, la cui stagione di gloria durò lo spazio di un mattino, anch’essa soffocata per carenza di una vera motivazione esistenziale, ad opera dei suoi più vitali elementi.
Realismo e neorealismo
Ho veramente la curiosità e la necessità che, fra i tanti che ne parlano e ne scrivono, qualcuno mi sappia spiegare l’effettivo significato dei termini realismo e neorealismo applicati al mondo della fotografia.
Iniziamo con il secondo. Perché neo? A rigor di logica si dà per scontato che vi sia stato un realismo precedente. Ma dove e quando?
In Italia facevano testo – in campo amatoriale – le foto di Peretti Griva, di Cavalli e di Vender; il fotogiornalismo professionale era pressoché inesistente, limitato alle foto – quasi sempre anonime – degli agiografi del fascismo, grondanti di retorica mussoliniana, allineate alle direttive del Minculpop, tutt’altro che realiste. Il cinema d’anteguerra aveva d’altra parte prodotto film di tendenza tutt’altro che realista: per quanto io ricordo, eravamo fermi ai telefoni bianchi e alle pellicole di regime, da Luciano Serra pilota a Scipione l’africano.
Con tutta la buona volontà, il neorealismo nella fotografia italiana degli anni ’50 resta per me un profondo mistero.
Quanto al realismo, mi sembra di capire che molti studiosi e critici stiano attraversando una fase di ripensamento. Nella maggior parte sono concordi nel significato del termine: la fotografia realista dovrebbe essere quella che immerge i suoi contenuti nel sociale, mostra l’uomo, è impegnata socialmente.
Ma accettata questa definizione, quanta della fotografia italiana è veramente realista? Non è sufficiente mostrare i vicoli di Napoli, qualche scugnizzo, la casa di ringhiera, per accedere al soglio del realismo.
Né sono realiste le foto di Branzi, Camisa, Giacomelli, certamente valide da un punto di vista di contenuto e di forma, ma permeate da una sottile ironia, da una ricerca di composizione e di toni che denunciano chiaramente il contributo determinante della personalità degli autori nei confronti del soggetto affrontato.
[…] Riportiamo il problema a un più semplice concetto: non c’è stato un vero e proprio periodo realista della fotografia italiana. C’è stato, più semplicemente, un giro di boa, dalla foto di puro ma sterile compiacimento formale, nella quale l’uomo era solo macchietta per scenette di genere, a una foto non tanto impegnata né immersa nel sociale, quanto più matura culturalmente, più attenta al contenuto e alla forma […].
Non si può riunire tutto sotto il grande ombrello dell’impegno sociale e del folklore del Sud per dare a tutte le foto (come a tutti i film) il diploma di neorealismo.
Il neorealismo – almeno a parole – era diventato di moda: questa “etichetta” faceva presa su tutti coloro che – a metà degli anni ’50 – per motivi culturali, non avevano assimilato e rielaborato le nuove tendenze.
Prevaleva il neorealismo sbracato e straccione, la scenetta di genere, la foto macchiettistica. In altri, coloro che portavano avanti questa tendenza, allora di avanguardia, con coerenza, idee e apporti nuovi non per moda ma per effettiva spinta interiore, questa forma espressiva si presentò come un realismo (ma perché neo?) “reinterpretato”, realismo grafico, nel quale la forma, la scelta a volte esasperata dei toni equilibravano o addirittura prevalevano sul contenuto della foto.
Realismo del paradosso (creato, o cercato, od a volte anche casuale), ma comunque paradosso. Emblematica, per ciò che ora diciamo, la notissima immagine di Branzi Bambino con l’orologio.
Quale neo-realismo?
(Appunto lasciato sul libro dei commenti alla mostra Il reale in figura. Fotografi nella stagione del Neorealismo il 29 giugno 2001 a Milano)
Non so se sia mai esistito un vero “realismo” nella fotografia italiana, ma il “neorealismo” è veramente solo una invenzione mutuata dal cinema e dall’intellettualismo degli Aristarco della fotografia. Non ditemi sempre che sono cattivo: cerco solamente, alla mia età, di essere sincero e di esprimere liberamente le mie opinioni.
Guardiamole bene: quante di queste fotografie sono veramente realiste e quante sono solo scenette di genere o ricerche dell’effetto smaccato […] che non rivelano la personalità del fotografo, mancano di ricerca tonale e formale, trascurano l’aspetto compositivo […].
E Mario Giacomelli, è certamente un grande, grandissimo fotografo, ma non certamente realista (né lui mai si considerò tale)!
E gli altri, quelli che – con le dovute cautele – potrebbero più rispondere a questa etichettatura (non facciamo volutamente i nomi), dove sono?
Scusate il commento prolisso, ma a volte aprire gli occhi e far aprire gli occhi ai visitatori ignari e mostrar loro il re nudo, può essere un’“operazione culturale” utile a far vedere che non tutti sono gregge.
P.S.: è ovvio che molte di queste foto sono valide, alcune validissime. Ma non metterei “etichette” ove non siano veramente necessarie.
Ditemi se questo è realismo o è solo nostalgica ricerca del tempo, di un mondo che fu
Eravamo al continuo inseguimento, al tentativo di fissare – su pellicola, almeno – gli ultimi esemplari di una umanità e di una civiltà secolare, ma ormai in via di rapida estinzione, che trascinava con sé i suoi simboli, le sue icone più appariscenti e significative. In pochi anni andavano disgregandosi e scomparendo usi, costumi e civiltà dalle tradizioni centenarie, in alcuni casi millenarie.
La civiltà contadina, la civiltà artigiana e operaia, [furono] travolte da un rinnovamento tecnologico rispetto al quale non avevano saputo o voluto tenere il passo, ma anche abbagliate e accecate dai miti televisivi dilaganti, dal fascino delle ormai abbordabili utilitarie e dall’efficienza delle neonate lavastoviglie che indubbiamente affascinavano assai più rispetto alla battaglia del grano o agli otto milioni di baionette e ancor meno delle lacrime e sangue promesse da Winston Churchill a fronte della vittoria e noi tentavamo di raccogliere le ultime tracce inseguendo gli ultimi esemplari di questo mondo che ormai andava a disperdersi sempre più e ad avviarsi alla scomparsa.
E poteva forse solo esser tenuto in vita sovrapponendogli una serie di abbellimenti, di mascheramenti e di orpelli che lo mantenessero (o che gli permettessero di rimanere) almeno esteticamente up to date.
Come ineludibile corollario a questo storico sconvolgimento della società italiana ha fatto seguito, fatalmente la progressiva scomparsa di tutto quel tessuto che ne costituiva l’ossatura, divorate dal progresso, dalla emigrazione, dall’industria, o semplicemente abbandonate in cambio del miraggio, della speranza di una vita migliore.
Scomparse una ad una le osterie, le “botteghe”, le rimesse dei cavalli, gli “antri” dei falegnami e dei fabbri ferrai, dei riparatori di biciclette e delle friggitorie, i carretti con la punta a gondola degli ambulanti di trippa […]. Scomparsa la vita in comune dei vicoli e della case di ringhiera, aboliti i casini, finito quel mondo tanto caro a Pratolini e a Gadda, al Sergio Leone di C’era una volta in America, a Hine e tutta quella umanità che ne era il tessuto connettivo, il collante.
Da questa umanità sofferente e insieme folkloristica traeva la sua linfa la fotografia più impegnata: era forse questo il vero realismo del quale ora si discute da decenni e si cerca di appropriarsi a diploma dell’appartenenza ad una elite artistica che invece non ci appartiene, e non ci si accorge che si cade nel più “trito macchiettismo”, nelle scenette di genere. Manca il background culturale. Si cerca di riprodurre un mondo che non c’è più mantenendone la vis poetica, e sostituendo l’ambientazione, l’abbigliamento, i tratti somatici con altri e altrettanto non validi valori.
Considerazioni sul realismo
Che cosa vuol dire in fotografia Realismo?
Supponiamo, da un punto di vista puramente grammaticale: una foto che parta da un soggetto reale. Ma la stragrande maggioranza delle foto partono da un soggetto reale, comprese le nature morte e composizioni (salvo le “astratte”).
Facciamo allora un passo avanti, e delimitiamo ancor di più il campo. Una fotografia nella quale appaia l’uomo, il suo modo di vivere, i suoi problemi. Ma espresso, mostrato e interpretato come?
La mia foto Elezioni in Sicilia, le foto Bambino con orologio e Nozze a Siviglia di Piergiorgio Branzi sono indagini sociologiche, immersioni nel sociale o rappresentazioni obiettive della realtà o denunce sociali?
Certamente niente di tutto questo, che sarebbe poi ciò che conferisce ad una foto la “patente” di realista.
E sono le scenette di genere, le scene macchiettistiche o i bozzetti o le istantanee senza apporto compositivo o interpretativo (salvo magari un po’ di panni stesi alle finestre, o meglio fra casa e casa di un vicolo napoletano)?
A mio avviso “realiste” sono solo alcune immagini – felicemente riuscite – di fotogiornalismo, ma che rivelano, in forma e geometrie ineccepibili temi e circostanze che sono sempre esistiti e non sono nate col miracolo italiano degli anni ’50 né sulla scena di Ossessione, di Ladri di biciclette né dei film di Duvivier o di Marcel Carmè.
A mio parere si è voluto creare un movimento, un “filone” della fotografia che in realtà non esisteva come tale, conferendo al tutto un collegamento con il mondo del cinema […] e una patina, una strumentalizzazione politica che in effetti non rispondevano alla reale situazione della fotografia in Italia.
Io quindi – per quanto mi riguarda almeno – rigetterei questa definizione, che ritengo impropria e riduttiva, e riproporrei la discussione su questo tema prima che esso divenga uno dei tanti miti, in effetti inesistenti, uno dei tanti termini impropri facili a nascere, e poi duri a scomparire.
Appunto
Quanti realismi ci sono? Probabilmente uno per ciascun autore, e per ogni autore uno per ogni foto.
E allora non sarebbe meglio dire che la fotografia italiana ha abbandonato, nel volgere di pochissimi anni, i vecchi schemi, per guardare più da vicino – con più o meno convinzione e più o meno personalità – al mondo che la circondava, che non era più rappresentato da imbuti bianchi e da palline da golf, ma da uomini, donne, bambini reduci da una guerra che li aveva drammaticamente coinvolti tutti, lasciando tracce difficilmente rimarginabili?
La mostra. Un commento critico
(Scritto in occasione dell’incontro Immagini italiane tra realtà e realismo,a cura di Cesare Colombo. La mostra a cui fa riferimento è Gli anni del neorealismo. Tendenze della fotografia italiana, catalogo FIAF)
Bella mostra, non mostra di belle foto. Importante da un punto di vista storico: illustra chiaramente il breve ma irreversibile periodo della “svolta” della fotografia italiana.
[…] Ma, volendo fare i critici ed esprimere liberamente il proprio pensiero, si possono fare alcune obiezioni di fondo.
Dato che è stata concepita soprattutto per un pubblico non profondo conoscitore della storia fotografica, questa Rassegna ha due peccati originari alle spalle: primo, non fa vedere quello che era stata ed era la Fotografia in Italia sino a quegli anni; secondo (più grave), perpetua, almeno nel titolo, la contestabile, e da me contestata denominazione del cosiddetto realismo, o peggio ancora neorealismo, che rischia di diventare un mito.
In Italia non c’è stata, nel settore fotografico, la nascita di una nuova scuola di pensiero o tanto meno di espressione. È solo cambiato, nel volgere di un brevissimo tempo, il modo di fotografare e il tema delle immagini, e questa mostra ne rivela la nascita. Ma da questo a parlare di realismo, ce ne corre.
Realismo vorrebbe significare impegno nel sociale, una funzione programmatica di denuncia, forse addirittura una finalizzazione “politica” (in senso lato) dell’immagine fotografica. Una fotografia nella quale appaia l’uomo, il suo modo di vivere, i suoi problemi.
[…] Ma quelle qui esposte, che sono certamente rappresentative della “svolta” della Fotografia Italiana degli anni ’50, sono effettivamente foto realiste?
Fotografare lo spazzacamino con la faccia dipinta di nero o i bambini alla giostra, o i vicoli di Napoli con i panni stesi da finestra a finestra non significa fare del realismo, ma solo macchietta, scenetta di genere, folklore meridionale per turisti stranieri. E quanti “realismi” ci sono? Probabilmente uno per ciascun Autore, e per ogni Autore uno per ciascuna foto. Tanto che, per le foto mie e di Branzi, sono addirittura stati coniati dei sub-realismi. Eccone un piccolo campionario: “realismo metafisico”, “realismo formalista”, “fotogiornalismo documentario”, “fotografia lirico realista”, “fotografia realista e d’ambiente”, “realismo grafico” (o “realismo reinterpretato in chiave grafica”), “realismo estetizzante”, “realismo soggettivo”, “realismo con anima”, “realismo poetico”.
Ma, obiettivamente, si possono definire “realiste” foto come Bambino con orologio o Processione di San Gennaro di Branzi, i pretini di Gacomelli o le mie foto della serie “Bancarelle” o Siesta?
[…] Allora, lascerei perdere le pretenziose etichette, e andrei semplicemente a vedere cosa è successo alla fotografia in Italia in quegli anni, e perché.
E lasciamo che Ladri di biciclette, Riso amaro e Il cammino della speranza (e perché non qualche film francese?) si riapproprino di una terminologia creata, in fondo, proprio per loro.
Una voce fuori dal coro: realismo in fotografia esiste veramente?
Da un po’ di tempo e con frequenza direi esponenziale, libri, riviste, mostre, cataloghi, articoli, saggi e altri ci inondano con la parola “realismo”. Nella mia insonnia sono riuscito persino a trascinare con me questo vocabolo/incubo. È riaffiorata nella mia mente e ha preso sempre più consistenza una personale assai lontana sempre covata perplessità: probabilmente questo realismo e le sue filiazioni in realtà non esistono.
È solo una nostalgia rivisitata, un ricordo e un sogno di un mondo che non esiste più, che anni di un garibaldino della fotografia hanno veduto e tramandato ad altri e trasformato in leggenda o semplicemente in effimera moda da esibire a un pubblico non molto preparato sull’argomento che non sa neppure ove stia di casa, che non sa neppure come vada composta o letta una foto, a spacciare per neorealista una immagine scattata davanti al bar del paese vicino, con atmosfera da dopoguerra, panni stesi, vecchietti con tante rughe e poche calzature.
E questo sarebbe il “realismo”? e la forma, la composizione, il contenuto vero dove sono?
Per me le foto degli anni che furono, i bistrot di Brassaï, la Fame in Sicilia di Patellani, il Soldato con la bicicletta e con le ghette che torna a casa l’8 settembre di Capa, il Delta di Donzelli, Le raccoglitrici di cotone della Lange, se vogliamo anche i carabineros di Smith potrebbero portare una etichetta realista, ma in realtà non vanno etichettate, sono semplicemente della immagini che, da sole, fanno capire un mondo.
Ed è quel mondo, il ricordo di quel mondo, che, secondo me, noi possiamo chiamare realismo, un sentimento che non è una classificazione di comodo per foto di scarso valore e di maniera.
Questa è la mia idea, del resto già espressa in varie circostanze.
La rappresentazione di un mondo che fu, che alcuni di noi hanno vissuto in prima persona e che è quello che ci affascina ed ancora affascina chi non lo ha vissuto. Non il pubblico che crede bella la foto, che invece bella non è. Non è certo una bella foto quella che ho scattato nel 1951 in un desolato piazzale di un paesello del profondo Sud. Qui un rudimentale cubo bianco di mattoni intonacati, con l’insegna “Barbiere” e la scritta “Il mio rasoio carezza e non taglia. Viva De Gasperi viva l’Ita(g)lia”. Ma vale cento pagine di storia patria e non serve applicarle sopra l’etichetta “foto realista”.
E cosa vuol dire “affondare nel sociale”? Far diventare bella una foto che rappresenta un’osteria di periferia? Quello che viene visto dai più come “Neo-realista” sono in realtà testimonianze del mondo che è cambiato sotto i nostri occhi: testimonianze della vita contadina, di un mondo arcaico scomparso nel volgere di una generazione e non possono essere vedute semplicemente con gli occhiali di un Neorealismo di comodo. I bambini di Africo, laceri, senza scarpe e con gli occhi imbambolati, stipati in “bassi” con il pavimento di fango e conviventi con l’asino e il maiale sono del 1947, l’età dei nostri figli. E questo è fotogiornalismo, vero, mentre non è per la maggior parte Neorealismo. Ed era documento di vita, testimonianza verace e sincera del mondo che fu. Possono esprimere angoscia, nostalgia, ma non essere copie di un mondo scomparso.
La fotografia italiana negli anni 1955-1960: dal salonismo al cosiddetto “neorealismo”. Ricordi di un testimone attivo
(Dalla bozza originale per l’articolo A. Camisa, La fotografia italiana degli anni 1955-1960. Dal salonismo al neorealismo. Ricordi di un testimone “attivo” in «Semestrale dell’Archivio Fotografico Toscano», XVII, Giugno 2001, 33, pp. 31-47)
I club amatoriali erano ancora gracili, non avevano una fisionomia propria, si interessavano essenzialmente di raffinati (e superati) problemi tecnici (la stampa a bromolio, la solarizzazione, l’high-key).
Facevano eccezione “La Bussola” (gruppo “chiuso”, elitario, estetizzante, palestra di esteti e cultori del bello fotografico fine a se stesso, guidato e monopolizzato dall’Avvocato Cavalli, depositario delle verità crociane sull’Arte), “La Gondola” di Venezia (più club nel senso tradizionale, futura fucina di alcuni tra i migliori fotografi del dopoguerra quali Monti, Roiter, Berengo Gardin, Bruno) e l’Unione Fotografica di Milano (essenzialmente dedicata a mostre di cultura), che ebbe il grandissimo merito di importare e far conoscere, prima e unica in Italia, la grande fotografia internazionale.
[…] nella più assoluta ignoranza di quanto avveniva al di là dei nostri confini e condizionato da una fotografia nostrana tutt’altro che di avanguardia, anche io cominciai con le immagini che a quel tempo erano di predominante attualità: le nuvole bianche che si stagliavano in un cielo reso ancora più scuro da un forte filtro arancione, i gruppetti di suore nei vicoli medievali toscani, i vecchietti – possibilmente mutilati – che entravano (o uscivano) dai “vespasiani”, i fotografi ambulanti, i mendicanti e via dicendo.
[…] La ricerca di qualcosa di nuovo, l’apertura alle foto straniere […], anche una iniziale inesperienza tecnica […] mi portarono – primo o fra i primi insieme a Branzi e a Monti […] alla “scoperta” di questo nuovo filone grafico. Una scossa e una reazione ai toni morbidi e sfumati, ai grigi tenui che facevano “bella” una fotografia di quegli anni […].
Su questi presupposti nacquero, nel 1954/55, le mie primissime Composizioni: geometrie fredde, asciutte ed essenziali, scarse o addirittura prive di toni intermedi […]: ricordo Finestra, La vetrina del Civaiolo, Inverno. E quelle, ad esse abbastanza omogenee di P.G. Branzi, pure del 1954: Giardino di Boboli, Circo all’aperto, Seggiovia.
Tanto bianco e tanto nero, tanti contrasti in contrapposizione alle ovattate nature morte dell’epoca.
Spiccava in particolare la drammaticità del nero, un nero catramoso che a volte prevaleva addirittura sulla luce abbacinante del deserto o sul bianco calcinato delle case del Sud.
[…] Anche io come gli altri miei amici, allargai i miei obiettivi verso orizzonti più vasti. Rimase nelle immagini il rispetto delle geometrie e della composizione rigorosa, la preferenza verso le tonalità contrastate, ma iniziò – timidamente – a comparire la figura umana. Che apparve, da principio quasi come supporto alla grafica, e poi sempre più rilevante, sino a essere il vero e unico soggetto del fotogramma. […] Dapprima piccoli fantasmi, ectoplasmi senza volto, senza personalità e senza storia, spesso figure mosse e sfuocate che appaiono solo per movimentare e completare lo scenario.
Si può affermare che, superata questa fase, da quel momento la fotografia dei più avanzati autori italiani non fu più la stessa: l’uomo, la figura, la figura “ambientata” soprattutto, presero il sopravvento divenendo il soggetto principale delle immagini dei fotografi italiani.
[…] La fotografia italiana, quella vera e vitale, stava per affrancarsi dal passato aggiornarsi a livelli più internazionali e professionali. E anche la prestigiosa ed elitaria “Bussola”, malgrado la cooptazione di giovani leve e la fresca linfa apportata dalla creazione di una sorta di “camera di compensazione”, battezzata da Cavalli come “Gruppo Misa” […] dovette rassegnarsi ad alzare bandiera bianca, dissolvendosi poi di fatto nel 1957.
[…] Penso che ogni fotografo, più in generale ogni creatore di immagini, consciamente o meno, abbia avuto un modello, un punto di riferimento, una fonte di ispirazione.
Per quanto riguarda il mio percorso, certamente ebbero un influsso considerevole le foto di Dorothea Lange sugli anni della depressione in U.S.A. per il loro drammatico contenuto, la descrizione dell’atmosfera di povertà e di squallore perfettamente rese in ogni singolo fotogramma, asciutte essenziale e prive di retorica. Il tutto con rispetto “naturale” dei valori formali.
E Walker Evans, troppo poco conosciuto al di fuori dei confini U.S.A., e invece così essenziale nella resa degli ambienti dell’America degli anni ’20, resi moderni da grafismi e accurati dosaggi di geometrie che solo lui riusciva a vedere e “reinterpretare” in un fotogramma.
E poi Eugene Smith, in particolare il suo Spanish Village: quei carabineros con le loro feluche di cartone nero sotto il sole abbacinante sono ritratti indelebilmente impressi nella mia memoria. Immagini forse un po’ letterarie (ma quelli erano gli anni di Hemingway: la sua Spagna di Per chi suona la campana era una tappa fondamentale della letteratura per i giovani intellettuali della nostra generazione).
[…] Alla fine degli anni ’50 alcuni di noi – quelli che forse avevano dato la maggior spinta propulsiva alla “svolta” – chiudevano la loro esperienza fotografica. La chiudevano con una “etichetta”: eravamo stati, senza saperlo, i fotografi “realisti”, anzi “neorealisti”.
Così definisce la fotografia di quel periodo C. A. Quintavalle in una recente presentazione di A. Migliori: «Neorealismo: una visione della realtà basata sulla supremazia del “popolare”, con le sue derivazioni di regionalismo e umanitarismo. […] In fotografia c’è più di un tipo di neorealismo».
E I. Zannier: «per i neorealisti era soprattutto importante la capacità di “mostrare” una situazione, per lo più i luoghi del degrado sociale […] di gente disperata nella quotidianità di una vita di sacrificio e di lavoro duro; molti di noi […] fummo “plagiati” da quest’idea di “realismo”».
Secondo la presentazione di una recente mostra su questo tema: «Il neorealismo italiano rinnovò, con la letteratura, la fotografia e il cinema, l’estetica del dopoguerra. […] Fu un movimento etico ed estetico conosciuto dal grande pubblico quasi esclusivamente grazie al cinema, nel quale la fotografia giocò un ruolo importantissimo, rompendo con la tradizione che rifletteva solo il bello, per convertirsi in documento della realtà circostante».
E nella medesima pubblicazione, in uno scritto di E. Viganò: «Come si potrebbe definire il neorealismo nella fotografia italiana? […] Come un affresco dell’Italia dipinto da coscienze differenti fra loro ma che, senza dubbio, utilizzano il medesimo linguaggio».
Mai termine fu – secondo me – meno appropriatamente attribuito per definire la nuova fotografia. È troppo semplicistico e approssimativo definire una certa tendenza della fotografia, che ebbe addirittura sviluppi ed espressioni diverse tra autore ed autore, sotto un’unica, semplice e non appropriata “sigla”.
Le nostre foto di quegli anni rispondono a questi canoni? Il soggetto delle nostre immagini era sì formalmente legato alla realtà quotidiana, ma cercava di reinterpretarla e arricchirla con una vena ora ironica, ora di tristezza e di malinconia concettualmente e formalmente distante dal filone del macchiettismo e dal bozzettismo di maniera imboccato da quanti ne avevano colto solo gli aspetti più superficiali.
C’era, nelle nostre immagini, una accuratezza formale, una scelta dei toni, una ironia, a volte una melanconia di fondo, una cura per la composizione, una ricerca e quasi un compiacimento dei dettagli dell’ambiente che la facevano appartenere ad un mondo diverso.
Le definizioni sono sempre artificiose, approssimative, semplificatrici.
Volendo forzatamente racchiudere questa esperienza in una casella con tanto di “etichetta”, potremmo coniare un “realismo lirico” che meglio definirebbe le nostre immagini. Me forse è meglio concludere che vari realismi convivevano. […] “Realista” vero era che faceva fotogiornalismo […]. Mentre certamente non lo era Giacomelli, pure impropriamente accomunato, in tante pubblicazioni, in questa “categoria”. Giusta ed enigmatica la sua definizione: «Considerando che ogni realismo è differente dalla realtà, la realtà si trasforma in immagini, e l’immagine che noi vediamo si converte in realtà».
E tanto meno lo erano gli imitatori e gli orecchianti timorosi di perdere l’opportunità ma incapaci di comprendere il vero significato della nuova fotografia, che doveva chiamarsi realista e non era altro che “sbracata retorica dei panni sporchi” citata e giustamente bollata da Paolo Monti.
[…] Forse, a suo modo, uno dei pochi che poteva, con proprietà, venir definito realista (ma solo per una porzione della sua produzione) fu Pietro Donzelli. Il suo fu un realismo acculturato, romantico, “alla francese”, forse un po’ datato e di retroguardia […].
[…] «Il Mondo» pubblicava immagini più raffinate, di satira del costume, spesso velate di un sottile umorismo.
[…] La redazione non disponeva di propri fotografi; Pannunzio accettava ben volentieri la collaborazione di fotografi esterni, anche appartenenti al mondo amatoriale. Nei primi anni di pubblicazione del giornale i nomi degli autori non venivano neppure citati; Pannunzio sceglieva personalmente le immagini, a suo insindacabile giudizio, pagava poco e solo dopo una interminabile fila di solleciti.
Ma avere una foto pubblicata su «Il Mondo», specie se in prima pagine, era per un fotografo un fiore all’occhiello, un privilegio e un onore per pochi appartenenti alla schiera degli eletti.
Raccolta di “mozziconi” di appunti trovati su foglietti sparpagliati
Che cos’è la fotografia? Trascuriamo le eterne e sterili disquisizioni sulla fotografia come arte che lasciano il tempo che trovano.
Per me la fotografia è la rappresentazione “rielaborata” della realtà (o, se preferite, una rielaborazione personale della rappresentazione della realtà). Ove in “rielaborata” vi sta dentro tutto: in chiave tonale, formale, compositiva, poetica, lirica, ironica, e via dicendo.
Il “bello” in fotografia. Nei primi cinquant’anni del secolo (scorso) si è tanto parlato (e scritto) del “bello” in fotografia. Secondo me, il “bello” in fotografia in effetti non esiste: esiste solo la bella fotografia. Se vogliamo fare un’analisi più dettagliata, ogni immagine è la sintesi di due fattori: forma e contenuto, che contribuiscono con peso diverso all’esito finale. Forma è composizione, tagli, equilibrio, gioco delle tonalità ecc.; contenuto è emozione e rendere un’atmosfera. Può essere pura forma (Monti, Angelo a Venezia e Giacomelli, Paesaggi) o solo contenuto (ed è già più difficile, il contenuto bisogna saperlo cercare, o saperlo trovare): Capa, Giacomelli (Vita d’Ospizio).
Ma il totale deve sempre fare cento.
Messaggio scritto in occasione della Cerimonia di presentazione del volume Il fotografo dell’anno 2007 (maggio 2007)
Signor Presidente, Carissimi amici,
grazie, grazie, grazie. Grazie per aver pensato a me in questa circostanza, grazie del riconoscimento, dell’onore e della onorificenza conferiti al mio lavoro.
Desolato di non poter essere oggi con voi e fra voi nel ruolo di “garibaldino” superstite che ormai mi spetta d’ufficio in questo genere di manifestazioni.
Ma un modesto ringraziamento lo dovrete pure voi a me, che con la mia forzata assenza vi risparmierete l’immancabile “sarò breve”, seguito da un ineluttabile discorso che poi, nel mio caso, molto spesso, si trasforma in animata discussione “per dissensi ideologici” sugli argomenti trattati (dal concetto di neo-realismo all’effetto formativo e didattico di Pannunzio e de «Il Mondo» e che persino ha gettato delle ombre poco benevole sulla sincerità degli argomenti trattati nell’intenso carteggio intrattenuto con Mario Giacomelli).
Ma torniamo alla FIAF. Voi tutti sapete che, alla fine degli anni quaranta, la fotografia amatoriale italiana più acculturata si trovava in buona parte raccolta e protetta, dal punto di vista organizzativo (Mostre, Concorsi, ecc.) stilistico ed ideologico, dal grande ombrello della FIAF, nata pochi anni prima ma probabilmente già dotata di mezzi, di capacità tecniche e organizzative e inserita in una rete a livello anche internazionale. […]
Io e uno sparuto gruppetto di amici ci ritrovammo automaticamente dalla parte opposta della barricata. Furono anni di animata attività e di contese ideologiche senza esclusione di colpi. Gli anni della nascita della “Bussola” (Manifesto del 1947), della “Gondola”, dell’“Unione fotografica”. Ne uscimmo un po’ ammaccati, ma la bandiera degli innovatori non venne mai ammainata. In molti lasciammo il campo, verso la fine degli anni cinquanta, con la FIAF ancora ben salda sulle proprie posizioni tradizionalistiche, conservatrici e salonistiche.
Riemersi da un più che trentennale letargo, proprio come nelle favole, grazie all’amichevole interessamento di amici coinvolti nella fotografia e nella storia della fotografia […]. Che cosa era successo nel frattempo nel mondo della fotografia amatoriale, di quella italiana almeno, e della FIAF, rispetto a quanto ricordavo?
[…] non so come, né perché né quando, né dove (le conseguenze di un Congresso un po’ surriscaldato?) ma di fatto era diventata un’altra cosa, una vera Associazione di larghe vedute, con ampia libertà di espressione a tutte le correnti espressive stilistiche, anche alle cosiddette “avanguardie”, con rispetto degli assetti organizzativi locali, con vedute extra-nazionali, largo interesse per l’attività culturale ed editoriale […].
Il vecchio garibaldino superstite ora può scendere dalle barricate e rientrare nei ranghi, felice che gli ideali per i quali cinquant’anni fa si era battuto abbiano trovato un loro spazio e siano tuttora validi, accettati e condivisi.
MOSTRE E RECENSIONI
La Mostra Nazionale di Padova
(di Ferruccio Zapponi, in «Fotografia», IX, aprile 1956, 4, p. 29)
[…] La Mostra di Padova è opera di Monti e non ce ne vorranno Guidi e Rizzoli se un fotografo riporta subito questa impressione: la personalità di Monti, vivissima nel nostro campo fotografico, traspare nella scelta delle opere, tanto da far sospettare che molti autori avessero già pronta la fotografia “alla Monti” per qualche eventualità che ora si è presentata (leggi Muro nero di Branzi, Ritratto di pittore di G. Bruno, Pozzo di luce di Ferin, Bottega di antiquario di F. Gasparotto, Averno di Chiavegato, Le chiavi di Camisa…).
Allora, qualche domanda ci viene spontanea.
Cos’è questa improvvisa fioritura dei Branzi, dei Camisa, Federico Gasparotto, Gino Oliva per citare i… più rappresentativi e i più premiati? Né vogliamo intendere se tali nomi – nuovi o no – abbiano diritto al gran premio o, meglio, alla accettazione (totalitaria) sebbene nomi, di pari o maggiore risonanza, ci siano sembrati accantonati […].
Branzi? Non citeremo Fiera campionaria o Muro nero (?) ma Una donna a Matera che ha l’onore di un premio (il terzo) e di una citazione in catalogo. Cromatismo? Pathos ambientale? Giuoco prospettico? Tutto da rifare?
Camisa? Questo giovane sforna parecchi lavori ma più che di un primo premio (davanti a quel po’ po’ di complesso di Roiter) ha, solo, bisogno di uno che gli dica di andarci piano e che una cosa è l’album di famiglia e altra cosa è la pretesa artistica. Sei opere accettate sono segno di affermazione concreta: ma dove? Ne L’uomo del bersaglio o nei Pescatori o in quella Siesta barocca e conformista (altro che impressionismo) o in quel Mazzo di chiavi? Camisa punta la sua macchina un po’ qua ed un po’ la, guarda ma non osserva, o, per lo meno, è un osservatore freddo: brutta dote per chi intende e pretende comunicare il proprio modo di vedere.
[…] Questo ciò che noi abbiamo visto dei risultati dell’opera di Monti a Padova. È superfluo aggiungere che, se qualche domanda abbiamo posta, è stata una auto domanda nostra di chi, qualche volta, pensa a dove andiamo a finire.
Un appunto sulla recensione alla Mostra di Padova
(di Alfredo Camisa e Piergiorgio Branzi, in «Fotografia», IX, giugno 1956, 6, p. 25)
Non siamo usi a entrare in polemica, e tanto meno a fare i fotografi-scrittori, come sta divenendo di attualità: a maggior ragione questo principio dovrebbe avere valore in questo caso, poiché polemizzare non è possibile con chi non porta qualche valido argomento a sostegno delle proprie critiche ma solo frasi generiche con molti puntini e punti interrogativi.
Visto però che il signor Zapponi […] ribadisce per l’ennesima volta e con termini poco cortesi e confronti di scarso buon gusto la sua completa incomprensione per le nostre fotografie, il porgergli un po’ di aiuto ci sembra quasi un dovere.
Benché accennare alla proprie convinzioni estetiche semplicemente per controbattere un articolo critico sia rispondere a cannonate alla puntura di una zanzara (specie se, l’articolo, critica concludente non ne fa), vorremmo chiarire al signor Zapponi che per noi non esiste, come per lui, una fotografia con l’effe maiuscolo e un’altra con quello minuscolo; una suddivisione in “grandi nomi” e in piccoli nomi (o “fioriture”); una categoria di fotografie per un tipo di giuria e un’altra per un altro tipo; un formato libero e un formato “a fette”; una fotografia di “avanguardia” e una di “retroguardia”; una fotografia da album di famiglia e una da Salone Internazionale.
Potrebbero non esistere i saloni, le mostre, i premi e le critiche: noi fotograferemmo egualmente, e come ora, perché non è in funzione di tutto questo che fotografiamo. Per noi la fotografia esiste solo come “emozione”, come possibilità di esprimere sinceramente e poeticamente la realtà, il nostro modo di vedere e di pensare, il nostro modo di vedere o di trasformare quel che ci circonda. Il copiare gli altrui “magistrali cromatismi” o l’altrui “potenza figurativa”, per giungere poi modestamente alla vuote e triste immagini dei minuscoli ometti vestiti di nero che camminano sotto i bianchi padiglioni della Fiera di Milano non ci interessa, francamente.
Noi fotografiamo per nostra soddisfazione: e la soddisfazione nasce dalla creazione di un risultato che ci parli e commuova, non dalla copia delle altrui esperienze o dal ricalco sino alla nausea di un motivo o di uno schema felicemente riuscito.
E soprattutto non guardiamo al risultato delle Mostre come alla classifica del giro d’Italia.
Se poi qualche giuria, formata da uomini “artisticamente validi e preparati”, e quindi forse abbastanza competenti al giudizio, crede opportuno premiare, qualche volta, una nostra foto, questo non ci esalta: solo ci consola.
Qualcheduno (meglio se non è fotografo: le emozioni non sono del resto appannaggio riservato ai soli fotografi) ha sentito ciò che, con le nostre immagini, noi volevamo esprimere.
E quando questa sensibilità sull’altrui operato manca, il critico obiettivo può confessare la non comprensione o apportare qualche argomento esteticamente valido alla propria disapprovazione: l’attacco inconcludente e con vuote espressioni è solo indice di mancanza di sensibilità e di buon gusto.
Una critica alla critica
(Intervento scritto in occasione del Secondo concorso fotografico “Città di Sesto” Villa Zoorn, 24 giugno-6 luglio 1956, Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni)
Insieme ad un amico, nel rispondere brevemente giorni addietro a un articolo molto polemico e poco critico che ci toccava da vicino apparso su una Rivista, esprimevo un certo disappunto per trovarmi occasionalmente nel novero di quei fotografi che, da un po’ di tempo a questa parte, amano trasformarsi in critici e scrittori.
Anche se tante e facilmente immaginabili ragioni portano a non giustificare od incoraggiare tale intervento diretto dei fotografi, almeno un motivo che può servire a spiegarne la causa esiste.
Abbiamo infatti una critica con preparazione, competenza e cultura generale e specifica tali da permetterle di avallare le proprie asserzioni con argomenti esteticamente validi, di fare dei confronti con le altre arti figurative, presentando il fatto fotografico nel quadro delle altre espressioni artistiche, di permetterle di esprimersi con proprietà di termini e di linguaggio, di fornire citazioni documentate e dati su quanto di valido si è fatto in fotografia da cent’anni a questa parte? Una critica che possa infine dare garanzia di serietà, di obiettività, che possa portare un contributo alla fotografia e alla cultura fotografica italiana?
Chi è abbastanza dentro nel mondo della nostra fotografia non può rispondere che negativamente.
E questo non è chiedere troppo: se arte infatti la fotografia vuol considerarsi, come le arti tutte necessiterà, da parte dei critici come da parte dei fotografia, di una seria preparazione estetica, di una conoscenza storica della fotografia, delle tendenze, delle opere dei più rappresentativi Autori.
Del tanto materiale che sommerge le Redazioni, quanto invece ha un valore che lo elevi solo di un poco dalla fraseologia vuota e stereotipata presa a prestito dai manuali di storia dell’arte, dalla retorica, dal dilettantismo e dall’improvvisazione, dall’umorismo di bassa lega, dall’incensatura o dalla palesemente astiosa stroncatura? Quanti gli scritti che sappiano descrivere o lodare una foto con termini un poco più ortodossi e comprensibili di quel “cannonata”, più volte rilevato, che né il Croce né il buon senso dei profani saprebbero tradurre in più appropriati termini di estetica o di poesia?
Diretta conseguenza di questo è l’assenza di scritti sulla fotografia da quotidiani e periodici non specializzati; il disorientamento del pubblico e dei fotografi; il perpetuarsi della mancanza di un gusto e di una sensibilità; il vuoto assoluto nel campo della cultura fotografica storica ed estetica, limitata al conformismo più agnostico. Conseguenza estrema è lo statico basso livello della massa della nostra produzione fotografica. Allorché Smith aveva già mostrato, con le immagini della Guardia Civil e del villaggio di Deleitosa, il volto della Spagna, quando Cartier Bresson ci aveva già dato le sue impressioni di Scanno, Strand la sua Francia minore, Steinert, per passare a tutt’altro campo, le sue immagini soggettive trasfigurate e anticonformiste, pochi di noi conoscevano tutto questo, il gusto dei fotoamatori era ancora polarizzato sui toni alti delle uova su sfondi sfumati, sulle vele bianche sul mare, sulle scenette di genere e le geometrie di scalinate.
Impressioni di Sicilia
(di Guido Bezzola, presentazione della Mostra fotografica tenutasi presso la Biblioteca Comunale di Milano nel 1956)
Alla Biblioteca comunale, Alfredo Camisa espone una trentina di sue foto, dal titolo complessivo Impressioni di Sicilia. È tornata di moda la Sicilia in questi ultimi vent’anni, da quando Vittorini e Brancati la riscoprirono rispettivamente nel suo volto tragico e in quello ironico, e si è prestata a molti esercizi letterari e figurativi di valore alterno; specie quando si cadeva nella decrepita retorica del popolo mediterraneo e solare. La verità come sappiamo, è un’altra: la Sicilia è una terra impoverita da secoli in cui, per la sua stessa povertà, in talune zone si sono perpetuate forme sociali e di costume altrove da gran tempo sparite; soffermarci su tali forme in sé e per sé, assaporandone unicamente l’aspetto estetico è comodo, ma anche inutile e ozioso […].
Se un appunto si può muovere a Camisa, esso sta forse proprio in ciò, nell’aver sorpreso e studiato aspetti della vita siciliana in sé verissimi, ma che non corrispondono forse più come un tempo alla realtà strutturale completa dell’isola; la sua documentazione […] si è volta soprattutto a una verità quotidiana, di una vita in cui scorre sangue nero e greve, in paesaggi calcinati dal sole, ove la figura dell’uomo si incide con forza tragica, e la natura non è amica, ma distaccata ed assente. Parlare di grecità è un luogo comune quando si discorre della Sicilia, ma è certo che l’aura diffusa di vita antica e misteriosa che si riscontra in parecchi luoghi della Grecia d’oggi, nel riverbero dei muri bianchissimi e nelle macchie scure dei vestiti neri delle poche donne, è presente anche in Sicilia, come per una sottile comunanza di spiriti.
Le immagini di Camisa sono tutte belle: […] ha inoltre avvertito profondamente il senso per così dire verghiano della terra di Sicilia. Foto come Vecchia stalla o La tonnara abbandonata o L’ultimo binario sono interpretazioni vere e proprie di temi tratti da I Malavoglia o Mastro Don Gesualdo, interpretazioni impostate e condotte molto bene, con sicurezza di gusto e di tecnica. Camisa ha visto e studiato le opere dei maggiori fotografi stranieri, da Bischof a Cartier Bresson, ma ha lasciato che una tale esperienza fosse soltanto esperienza, e per il resto ha fatto da sé: in questa serie siciliana i voluti fortissimi contrasti […] evocano subito il tema ricorrente del sole a picco e sottolineano con efficace crudezza le semplici e severe composizioni di linee in cui le figure umane si iscrivono e si concludono.
Immagini d’Africa
(di Ernesto Treccani, presentazione della Mostra fotografica tenutasi presso la Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni nell’aprile 1957)
Per me pittore, in particolare, il mondo della fotografia riveste un immenso interesse. Per quella sua facoltà di “fermare” una realtà in perenne mutazione, di sottolineare l’attimo essenziale, l’atteggiamento complesso, in un equilibrio estremamente instabile e passeggero.
[…] Ma quando questa si compiace nella imitazione della pittura perde la propria forza, il proprio carattere specifico di mezzo per narrare figurato.
[…] Ma quanto più è documento, quanto più può approfondire la conoscenza della realtà umana, risolvendola nelle forme dell’arte, la fotografia si caratterizza e trova la propria ragione espressiva.
[…] Lo stile di Camisa, le cui immagini sono state per me una felice scoperta, colpisce per l’alto fuoco con cui si precisa l’immagine non facilmente dimenticabile di questa sua serie dedicata all’Africa. Qui le alterazioni di tono, i neri bruciati e i bianchi abbaglianti, conferiscono all’immagine una forte carica espressiva e mostrano il contributo soggettivo che il fotografo può apportare per creare una propria visione della realtà. Quando si sofferma sui personaggi, la fotografia di Camisa è “ambientale” più che psicologica; in ogni immagine si sente la ricerca di un legame con la vita, la visione dell’uomo non come semplice compiacimento estetizzante compositivo e formale, ma come elemento indissolubilmente legato all’ambiente. E anche qui deformazioni e alterazioni tonali sono funzione dell’indagine ambientale e psicologica, della descrizione dell’atmosfera.
Esemplare a questo proposito, quell’acuto lampeggiare dello sguardo del bimbo nell’oscuro dell’ambiente della “Scuola Coranica”, toccante e assai difficile a dimenticare.
Due processioni nel Sud
(di Guido Bezzola, commento alla mostra di Camisa e Branzi presso la Biblioteca Comunale di Milano, in «Fotografia», XI, maggio-giugno 1958, 4, p. 31)
Con Due processioni nel Sud Camisa e Branzi hanno voluto darci due studi di costume, in ambienti teoricamente affini, in pratica estremamente diversi. Non basta infatti dire Sud per accostare dei riti che, da Napoli a Caltanissetta, mostrano in comune solo l’amore per lo sfarzo e l’ostentazione, per la religiosità barocca e istrionica, per la proiezione all’esterno di fatti e moti che dovrebbero essere solo interni. In realtà, però, quanto Napoli appare giocosa fantasiosa leggiadra, con un fondo insopprimibile di scetticismo e di gaiezza, altrettanto la Sicilia, e Caltanissetta per essa, è cupa e severa, avverte nella divinità la presenza dei numi antichi, non benefici ma anche ostili violenti e incomprensibili. La profondo malinconia della Sicilia, il nero sangue dell’isola intriso d’odio e di zolfo circola anche qui, e le immagini si fanno più dure, le espressioni dei volti meno elastiche, la religione diventa anche un fatto di ferocia e di passione, come se bisognasse ancora combattere per essa contro gli infedeli.
Più dolce, l’abbiamo detto, è il clima di Napoli, e soprattutto più gaio, più molle, meno teso: Branzi ha colto molto bene queste caratteristiche, sottolineandole con gusto. L’effigie argentea del santo passa tra la folla, in un contatto umano che ha in sé un calore affettivo tutto partenopeo in un frantumarsi di immagini che corrisponde bene al policromo disperdersi e ricomporsi della folla, della vita, della luce napoletana, di fronte allo statuario atteggiarsi della Sicilia, terra di silenzi e di deserte distanze. Camisa invece ha posto attenzione soprattutto ai volti, ai tipi, alle persone umane che nell’occasione della festa si travestono, indossano le tonache delle confraternite, recano in giro per la città l’attestazione della loro fede dura e impietosa, ben lontana ancora dall’effettiva presa di coscienza delle possibilità del dubbio e dell’errore, più vicina a certe clamorose manifestazioni dei secoli o addirittura degli evi passati.
Nel complesso, forse la documentazione di Branzi è più completa e persuasiva (o era anche più facile?). La mostra tuttavia presenta un suo interesse notevole e può aprire la via a discussioni di vario genere, non soltanto artistiche e fotografiche […].
Fotografi Milanesi d’oggi: significato di una Mostra
(di Alfredo Camisa, in «Fotografia», XI, novembre 1958, 10-11, pp. 26-31)
Le luci che, nei giorni trascorsi, han dato vita alle 245 fotografie esposte al Palazzo Olivetti di Milano sono ormai spente: è giunto il momento di parlarne, di queste fotografie, di chiedere cosa questa
Mostra volesse e dovesse dire, e cosa in realtà abbia detto.
Ritorniamo indietro di un anno.
Quando, nella fase di impostazione, si è pensato di riuscire a varare una mostra fotografica di livello elevato con sole opere di fotografi operanti in una ristretta porzione d’Italia, forse si è giocato d’azzardo. E d’azzardo si è soprattutto giocato con un “manifesto”, ispirato dal gruppo “Il Naviglio” e firmato dall’Unione Fotografica, dall’Ottagono e dagli “Indipendenti”, che lasciava, in realtà, non molte alternative sulla impostazione e sulla tendenza della mostra.
Ricordiamolo, quel manifesto. Vi si constatava la incapacità della maggior parte delle mostre fotografiche di esprimere e valorizzare le correnti più vive della fotografia italiana; si ammetteva il superamento dei criteri salonistici tradizionali e si conveniva quindi di “concentrare l’attenzione su quelle manifestazioni che dessero garanzia di serietà e coerenza stilistica, e tali da costruire una chiarificazione dei valori e delle tendenze fotografiche”. E più avanti si auspicava, “senza alcuna esclusione aprioristica di modi o tendenze, una fotografia più aderenti ai tempi, tale da potersi inserire quale fatto vivo nel quadro culturale della nostra epoca”. E si affermava infine “la necessità che la fotografia uscisse dall’ambito ristretto dei fotoamatori, per estendere i contatti con la stampa non specializzata, la critica d’arte, gli ambienti artistici e il pubblico”. In altre parole, non si voleva limitare né l’argomento né la forma espressiva, ma, di ogni argomento, di ogni forma espressiva, solo scegliere quanto fosse realmente attuale, consono ai gusti d’oggi. E si voleva far uscire i fotografi dalla loro torre d’avorio.
Chiunque conosca il mondo fotografico nostrano capirà che, pure esponendo ovvi concetti, un simile manifesto non aveva molte probabilità di benevola accoglienza in certi ambienti. Se ebbe il sopravvento, ciò non fu certamente a pieni voti; fra i promotori d’allora ci fu chi digerì male il boccone, e chi non lo digerì affatto e se ne andò sbattendo l’uscio.
Questo dunque era il clima nel quale la mostra ebbe origine: con simili premesse è ovvio che l’azzardo cui accennavamo non era affatto immaginario.
Un anno è passato. E ognuno ha potuto osservare, giudicare e trovar risposta ai propri interrogativi. Noi pure. E abbiamo dovuto constatare che proprio nei due punti di debolezza, di maggior azzardo, nei due punti che più ci avevano lasciati perplessi all’inizio, la mostra ha trovato il suo significato e le sue ragioni di successo.
Chiunque sarà d’accordo, anzitutto, nel riconoscere che non fu un azzardo la fiducia nella riuscita di una rassegna che tenesse strettamente fede ai presupposti “geografici”. Qualitativamente la mostra ha rivelato al pubblico una serie di immagini di livello senza dubbio superiore a quanto normalmente è dato di vedere nelle numerose anonime mostre, nazionali e non, che affliggono il nostro mondo fotografico. La possibilità di presentare, di vari autori, delle piccoli “personali”; il lungo lavoro compiuto dalla giuria; la mancanza del flagello dei premi han certamente facilitato il compito. Comunque sia, si è formata una raccolta che, pur senza eccelse vette, meriterebbe d’esser conosciuta. Come esempio, se non altro, in tutti quei centri che si affannano nell’organizzare mostre provinciali, nazionali e internazionali, distribuendo onorificenze e gabellando all’ignaro pubblico per “Arte Fotografica” una produzione dilettantesca d’un gusto ormai superato e stantio.
Ed eccoci al secondo punto.
Il manifesto che aveva dato avvio all’iniziativa poteva essere rischioso: la strada che doveva condurre a valutare, in accordo con le premesse, opere di tanti autori, poteva nascondere mille trabocchetti, rischiava continuamente di imboccare la svolta della mostra “di tendenza”. Si trattava di non limitare l’argomento né la forma espressiva, di rendere la rassegna realmente “rappresentativa” cercando di vedere quanto di meglio ogni autore, ogni argomento, ogni stile, ogni tendenza, ogni forma espressiva poteva offrire, omogeneizzando nel medesimo tempo il tutto secondo un denominatore unico. Che si riassumeva nella scelta di una foto di gusto, il più possibile lontana dalla involuzioni salonistiche, una foto che mostrasse quanto più possibile, dietro di sé, l’uomo fotografo, la sua personalità, il suo sentire.
Si è raggiunto questo scopo?
Un illustre visitatore, preoccupato assai più delle parole del “manifesto” che della voce delle fotografie, il giorno dell’inaugurazione ebbe a dirci, con cortese metafora, che la mostra suonava come Paganini, su una corda sola. Fallimento, dunque?
Ci permetta, l’illustre e rappresentativo interlocutore, di ripetergli che dissentiamo.
Come di tutto ciò che non è assoluto, si potrà certamente discutere del valore delle foto, ma non certo affermare una loro omogeneità o la presenza di un’unica tendenza. Osserviamole, queste foto. Dalla fotografia “alla Klein” nella quale la grana è l’essenza dell’immagine (Rossi e Colombo), passiamo alle elaborazioni, in chiave più attuale, dello stile “salone” (Petraroli); dal soggettivismo (Bruzzone) e dalle astrazioni (Grignani) a diverse “gradazioni” di fotografia di reportage (Patellani, Niccolai, De Biasi). Dalla sofisticazione della moda (Della Valle) al realismo del suburbio (Vanoni); dalla westoniana ricerca della materia (Donzelli) alla sua smaterializzazione (Monti). Dal ritratto formale (Bacciocchi) alle interpretazioni personali del volto (Zovetti); dalla idilliaca interpretazione della maternità (Zovetti ancora) a quella tragica (Finocchiaro). Dall’aggressivo effetto del cartellone murale (Granata) ai morbidi toni della solarizzazioni di Veronesi, alla sottile malinconia che vela i classici paesaggi di Bolla e di Ferri.
Potremmo continuare. Ma queste citazioni dovrebbero essere sufficienti ad un ripensamento, dovrebbero convincere che né argomento né forma espressiva risultavano monocordi, che solo si è cercato di scegliere il meglio, il più “attuale”.
Anche per la fotografia il tempo passa, il gusto cambia. Il pittoricismo, la fotografia intesa come “miracolo” tecnico per la fedele, impersonale riproduzione della natura, han fatto il loro tempo, non sono più di moda. Già, di moda. Scandalizza molti, questa parola, impiegata nel campo dell’espressione.
Ma che cos’è, la moda, in tutte le sue multiformi manifestazioni, se non l’espressione del gusto e del tempo in cui viviamo? Ci scusi, quindi, l’illustre e rappresentativo interlocutore, se, ora, più che mai, siamo convinti ch’era in torto.
E crediamo, quindi, nel risultato positivo della rassegna.
Padova 1958: divagazioni di un giudice
(in «Ferrania», XIII, febbraio 1959, 2, pp. 14-15)
[…] La poesia è in un volto come in un muro scortecciato; la commozione si può trovare in una scena di vita come in una metafisica astrazione; l’umanità può risiedere nel ritratto di un accattone come in una natura morta; la personalità dell’Autore si può ritrovare infine in qualsiasi soggetto, tono, tendenza.
[…]
La scelta di giurie eterogenee e non specializzate, aperte a uomini del mondo della cultura, la valutazione degli Autori per complessi di opere sono le garanzie di una effettiva serietà e gli indici della non ambigua posizione scientemente assunta da questa rassegna. […] Come antitesi, soprattutto, delle miriadi di manifestazioni fotografiche impostate all’insegna della superficialità estetica e della scarsa educazione culturale e fotografica. Manifestazioni nelle quali le fotografie da selezionare vengono accuratamente mescolate, come un mazzo di carte da scopone; questo mosaico decomposto, queste opere spersonalizzate e senza anima sono destinate a sfilare dinnanzi agli occhi di giudici muti, la cui dialettica si esaurisce nella pressione di un pulsante.
Il giorno dopo una pagellina perforata comunicherà all’Autore il “voto” meritato da ciascuna sua foto; fase di transizione, comunque, anche questa, in attesa della macchina-giudice, nella quale la foto entra, per uscirne sotto forma di cartolina perforata e affrancata da inviare all’interessato.
L’apparecchio sarà forse munito di un dispositivo di scarico che permetta una automatica eliminazione della foto per il loro soggetto non gradite alla giuria. Che avrà così autorevolmente occasione di affermare le proprie personali tendenze estetiche.
Rassegna della fotografia italiana a Sesto
(in «Popular Photography italiana», III, dicembre 1959, 12, pp. 72-77)
[…] Esistono forse due tipi di fotografi, e quindi di fotografia, dicevamo poc’anzi? No, ovviamente. La fotografia è una sola: pur se i mezzi e le limitazioni sono diversi, e a sfavore degli amatori, non è possibile per questo nel valutare la fotografia, adottare un fattore di correzione, due pesi e due misure (specialmente poi se, da una parte, si innalza a volte impropriamente il paravento dell’Arte…). Il fotografo, la fotografia, sono una cosa sola, anche se eseguiti con mezzi e per fini diversi: al valore dell’immagine del reporter derivante dall’aver colto l’attimo o lo spirito di una situazione potrà corrispondere, dall’altra parte, l’interpretazione poetica, l’immagine meditata, lo stile inappuntabile, la ricerca del tono o della forma. Del resto, il problema non esiste fuori dall’Italia, nei paesi fotograficamente più evoluti. […] facciamone poche, ma cerchiamo, nel farle, di impiegare la materia cerebrale. Come qui a Sesto cerchiamo cioè di fornire un panorama dell’intero campo della fotografia, o di una selezione dei migliori fotografi che si dedicano a un determinato settore fotografico. E dedichiamo, nelle riviste, maggior spazio alla fotografia applicata, alle serie fotografiche anziché alle singole immagini.
I dilettanti nostrani […] Cerchino di sprovincializzarsi, di guardare non già alla “bella” foto, ma alle serie di foto, alla foto che parli da sola […].
È il confronto tra le opere degli Autori che si considerano i “puri” della nostra fotografia e le foto di quelli che sono considerati i “mestieranti”. Da questo confronto, purtroppo, i “puri” escono piuttosto malconci. La loro fotografia, non vincolata da fattori commerciali o contingenti, potrebbe e dovrebbe essere un fatto puramente culturale: bozzettismo, macchiettismo, frammentarietà, incoerenza, superficialità, incapacità di saper “rendere” un ambiente sono invece i difetti che si notano più evidenti nelle foto degli amatori. Si potrebbe, giustamente, obiettare che non è richiesto all’amatore “raccontare” una storia. È vero, ma è anche vero che la fotografia è una sola, e a chiunque, se impiega un mezzo espressivo, è richiesto che sappia “dire” qualcosa. Se non raggiunge valori formali che la nobilitino non ha infatti valore, e rimane semplice virtuosismo o riproduzione.
Ma in realtà andando un po’ più a fondo, non è tra fotografi dilettanti e professionisti che si è notato il divario, ma piuttosto tra fotografi di tipo “dilettantesco” e fotografi di tipo professionale, tra mancanza di consapevolezza critica nell’impiego del mezzo fotografico e conoscenza delle funzioni del linguaggio fotografico. Alla mostra sestese infatti un certo gruppo di fotografi, da non considerare propriamente professionisti, ha mostrato di operare con un linguaggio che non permette distinzioni
[…]. Le loro fotografie presentano la prerogativa della curata tematica, della ricercatezza maggiore, della sottigliezza compositiva, dell’humour sottile che si mantiene sul filo senza cadere nella cronaca né nel macchiettismo. Caratteristiche peculiari delle immagini dei “demi-vierges”della fotografia italiana.
Alfredo Camisa tra Scilla e Cariddi
(di Antonio Arcari, in «Foto magazin», VI, ottobre 1961, 10, pp. 15-16)
Ci sono dei racconti, persino dei romanzi, degli affreschi e dei film che nascono spesso da una semplice idea, da una situazione, magari da una breve notizia di cronaca, che colpisce, o, potremmo dire con linguaggio più poetico, folgora, ispira, lo scrittore o il pittore o il regista, che intorno a questa idea poi costruisce con un più lento e ragionato processo di naturali illazioni e di premesse necessarie l’opera intera.
Nello stesso modo può nascere un libro di fotografia.
[…] Così, o press’a poco così, ci pare che debba essere nato il volume di Alfredo Camisa su Lo Stretto di Messina e le Isole Eolie.
Il nucleo centrale, o meglio gli avvenimenti che hanno folgorato la sua fantasia, o, più modestamente, attirato la sua attenzione sono facilmente individuabili e sono senza dubbio le cose migliori del libro, punti di maggiore interesse fotografico e documentario […].
Questi punti, dicevamo, sono quelli in cui Camisa si rivela narratore per immagini eccellente, e in cui senti che l’interesse umano si innesta spontaneamente, senza sforzo alcuno, con l’abilità del fotografo, in cui insomma il taglio, la scelta del punto di vista, il modo della stampa, la prontezza del reporter nei rapidi spostamenti e nell’agilità dei riflessi, la capacità di dar vita a un’azione con una misurata sequenza di immagini fanno tutt’uno con la sua emozione di uomo di fronte alla realtà.
Prendiamo la festa della ‘Vara’ e avremo subito conferma della profondità dell’interesse del fotografo. Una festa di antica tradizione e di tipo popolare-religioso: sarebbe stato facile cadere nella scenetta folkloristica di dubbio gusto, lasciarsi prendere la mano dai soliti bozzetti tipici. Camisa se ne è tenuto lontano e ci conferma così la intensità del suo sentire e la sua sensibilità di fotografo.
Lo stesso potremmo ripetere per la pesca del pesce spada o per le altre sequenza che compiono nel volume.
Su questi spunti di poesia, spesso drammatici, Camisa ha fondato il suo libro. E i problemi che si sono presentati è riuscito a volte a risolverli in modo del tutto soddisfacente. La linea di schiuma dello stretto, dove i due mari, Tirreno e Ionio, si scontrano, è una fotografia che fuori dal suo preciso contesto non si capirebbe, ma che si inserisce perfettamente nella sequenza del pesce spada, così come, nella stessa serie, dei mosaici antichi e un graffito d’oggi assumono il loro esatto significato proprio perché collocati al loro giusto posto.
[…] Non si pretenderà naturalmente che il libro conservi in ogni pagina, per ogni capitolo o per ogni sequenza, la stessa altezza di tono.
Il Camisa aveva trovato con la ‘Vara’ e con il ‘pesce spada’ una sua tecnica di illustrazione e questa ha cercato di trasferire in una buona parte del libro, intuendo certo che da questo il volume riceveva forza coerenza unità. Fotografie non soltanto genericamente buone in sé, ma che diventano tanto più significanti perché collocate insieme e che insieme dicono molto di più.
Questa serie di volumi può sicuramente vantarsi di essere ben poco convenzionale e “di volger l’occhio – come è detto nella presentazione di uno dei libri usciti – sul particolare umano, distogliendolo, talvolta, dal monumento e dall’opera d’arte”. E tuttavia il libro serve al turista, un turista disincantato sì, ma a cui il bel paesaggio piace, così come gli piace un’opera d’arte o un giuoco della natura.
[…] Dicevamo all’inizio che su un nucleo centrale nato da un momento di particolare ricettività e da una particolare felicità espressiva, il fotografo spesso sente la necessità di approfondire la sua conoscenza ampliando l’indagine. Ora Camisa ci pare abbia fatto questo solo fino a un certo punto, anche se a un buon punto, ma poi si è fermato ed è tornato un po’ sui suoi passi e ci ha offerto una serie di fotografie oneste, alcune anche lodevolissime, ma in cui è evidente la rinuncia di condurre fino in fondo la sua ricerca, di portare a termine in modo rigoroso e coerente il tema che gli stava più a cuore.
Organizzazione di una mostra
Milano, 2 marzo 1957
Egregio Signor Turroni,
le invio in visione un abbozzo della presentazione e del regolamento della Mostra-Concorso di fotografia che si svolgerà a Cairo Montenotte nella prossima estate, della quale Le ha scritto a suo tempo il Sig. Buzzone.
Dato che vorremmo realizzare una Giuria che si trovi il più possibile in accordo sulla impostazione della Mostra, e che possa quindi lavorare e selezionare nel miglior “clima” possibile, Le sarei grato se volesse indicarmi, su un foglio a parte, le eventuali obiezioni e modifiche che riterrà opportune (tenendo presente che la presentazione dovrà risultare il più breve possibile, per ovvie ragioni, ma anche il più chiara ed esplicita possibile), e di farmi riavere al più presto il tutto.
Nella speranza di poter fare presto, non altro in occasione di questa manifestazione, la Sua conoscenza, Le invio nel frattempo i miei migliori saluti.
Alfredo Camisa
Negli anni recenti la situazione della nostra fotografia si è evoluta, sino a giungere lentamente ma con costanza, a inserirsi nel campo della cultura. Sono stati posti in evidenza aspetti e problemi sinora ignorati (la necessità di una conoscenza della storia della fotografia, ad esempio); si è aperto un dialogo sullo “specifico fotografico”; si sono infine organizzati concorsi con criteri sempre più divergenti dalla ormai superata concezione delle “mostre di fotografia artistica”.
Nell’organizzare, a Cairo Montenotte, questa I Mostra Concorso di Fotografia, non intendiamo allestire semplicemente una rassegna da aggiungere al novero delle numerose altre che ogni anno si svolgono in Italia. Pensiamo che, per risultare positiva ai fini dell’evoluzione della fotografia, una
Mostra debba sempre porsi, su una posizione critica: vagliare quanto è stato fatto nel passato, aver presenti le nuove istanze che sempre sorgono dalle cose vive. E, sulla scorta del giudizio tratto, impegnarsi per apportare un contributo concreto.
E così, dall’osservazione obiettiva della situazione della nostra fotografia, senza entrare in valutazioni o prese di posizione “critiche” sulle tendenze o gli “specifici” della fotografia (in quanto consideriamo valido qualsiasi “genere”, purché risolto su di un livello di valore), si sono potute trarre tre importanti indicazioni.
La prima investe il criterio di premiazione. Riteniamo che la premiazione per complesso sia il miglior modo per giudicare il valore di un Autore e la sua continuità stilistica ed espressiva. La foto singola può essere frutto del caso: un complesso di più fotografie permette invece di giungere ad una valutazione più vicina alla reale qualità del fotografo.
In secondo luogo il problema del formato. Ogni fotografia necessita di una dimensione propria: il costringerla entro un formato “standard” è un errore che può incidere negativamente, oltre che ai fini dell’“impaginazione” della Mostra, anche sulla valorizzazione della singola fotografia.
Infine, ultimo ma non meno importante fattore, dal quale dipende gran parte della riuscita di una manifestazione, la formazione della Giuria. Essa dovrebbe essere composta da membri (anche non fotografi) che conoscano i problemi della fotografia nel molteplici aspetti che legano questa alle altre forme e manifestazioni della cultura moderna. La fotografia non si esaurisce nella cerchia dei “fotoamatori”: non avrebbe in questo caso che il valore di un “hobby”, che rifuggiamo.
Queste difficoltà sono da ritenere, nei nostri intenti, superate: ai fotografi si rivolge l’invito di ben comprendere le ragioni della nostra proposta e di collaborare alla sua realizzazione. Ma, affinché la Mostra risulti positiva e divenga una delle più elevate manifestazioni fotografiche nazioni, la buona volontà degli organizzatori non è sufficiente: essi non possono dare nulla di più delle garanzie di serietà, del sacrificio economico e della fatica organizzativa.
L’ultima parola, la più importante, dovranno dirla i fotografi.
LA CRITICA
Profilo di Alfredo Camisa redatto da Giuseppe Turroni nel 1957
Meldola, 2 luglio 1957
Caro Camisa,
le invio il testo per il catalogo. Naturalmente mi assumo pienamente la responsabilità dello scritto nel caso qualcuno – tra i non troppo elogiati – possa protestare. L’avverto di conseguenza che il testo è non mutabile.
[…] Intanto la saluto e spero che la sua, ormai famosa, lingua biforcuta, trovi in mezzo a tanta calura un po’ di requie. E perché – di grazia – la sfoga tutta addosso al mio principale, dico il buon Croci? Non trova, insomma, di essere abbastanza esageroso (sic!)?
Tante cordialità, comunque, e sinceri auguri a lei e famiglia, dal suo
Giuseppe Turroni
Tra i tanti “spiccatori di immagini” che lavorano sotto il segno dell’improvvisazione e di un “gusto” spesso discutibile, comunque frammentario e gracile, Alfredo Camisa può invece vantare, se non uno stile sempre e dappertutto riconoscibile, una propria ferma e composta personalità, che, al di fuori della maniera, di compiacimenti formalistici, di neo-edonismi calligrafici, lo porta a vedere la realtà secondo una dimensione di spietata oggettività, pervasa dall’amara luce intellettualistica dell’intelligenza contemporanea.
Camisa è giovane, domina sapientemente la tecnica, ha una sensibilità estroversa e analitica.
Come uomo, è curioso per natura. Come fotografo rende più acuminate queste sue qualità umane, più graffianti; affila la lama dell’indagine formale, per non essere imprigionato dalla sensazione “pura” ed estemporanea, dal sentimentalismo, dalla “bellezza” di certe visioni. Ci dà, ad esempio, un sud che non è soltanto calligrafia, non è soltanto forma di una mitologia neorealistica, ma espressione di un nuovo modo – privo, forse, di pietà – di vedere la vita e le cose.
Non è maniera, ripeto: potrà essere stile. Smaltita certa veristica (ed estetizzante) iconografia di gusto espressionistico, potrà essere, anche, sapiente e umano reportage.
Alfredo Camisa
(di Italo Zannier, in «Ferrania», XII, novembre 1958, 11, p. 2)
Nel fare il nome di Alfredo Camisa, viene spontaneo pensare anche a Piergiorgio Branzi e Mario Giacomelli.
Cogliendo gli avvertimenti e le esperienze dei grandi maestri europei e americani, distogliendosi soprattutto dagli improficui e scontati ricatti del “domenicalismo”, questo trio fortunato si è rivelato a un tratto a rinsanguare l’ambiente fotografico italiano.
Sin dalle prime affermazioni fu facile pensare e sperare che ben presto l’opera di questi tre giovani fotografi sarebbe stata non già il frutto occasionale e frammentario di un piacevole “hobby”, bensì di altrettante vivissime e coscienti personalità.
Giacomelli, che non ha troppo indugiato nelle affascinanti meditazioni paesaggistiche, ha potuto sviluppare le sue doti in una fotografia episodica, cinematografica, narrativa (Vita d’ospizio); Branzi sta interessandosi seriamente di una forma lirica di reportage, conscio della necessità del racconto fotografico, ritmato da immagine a immagine, di cui ha ormai concesso splendidi esempi (Processione di San Gennaro, le serie spagnole); Camisa infine ha abbandonato i suggestivi giuochi quasi astratti di finestre e gabbie metalliche, per riflettere il suo spiccato senso grafico in una fotografia anch’essa narrativa.
Questo desiderio, questa esigenza di rinnovamento dicono la serietà con cui essi si sono impegnati nella fotografia, portandovi la loro sensibilità aperta alle nuove voci e ai nuovi interessi culturali.
Ricordo alcune delle prime fotografie di Camisa: La vetrina dell’imbalsamatore, Dopo la pioggia, La finestra il cui interesse era concentrato in una assoluta preoccupazione compositiva di gusto neoplastico e in cui gli oggetti perdevano la loro funzionalità per divenire pretesti di luci bianchissime oppure di ombre decisamente nere, catramose, di rette verticali e orizzontali intersecate secondo rapporti rigorosamente geometrici. Le immagini divenivano rappresentazione tutta soggettiva, astratta. Ogni fotografia frutto di una personale acutezza visiva era una scoperta meditata e controllata, a volte eccessivamente cosciente e compiaciuta.
Invero fu proprio questo assoluto rigore, che ci portò anni orsono a osservare con particolare interesse il lavoro di Alfredo Camisa, questa volontà di costruirsi una poetica, una calligrafia precisa, aliena da ogni elemento arbitrario.
Portata a fondo questa esperienza formalista, Camisa si è accorto dei rischi che vi si nascondevano e ha così iniziato a inserire nei suoi esercizi grafici l’elemento umano, pur cercando a volte di confonderne la fisionomia, imprigionandola nel ritmo e nella materia dell’immagine.
I Mercati all’aperto di un paio d’anni fa, rappresentano il primo passo verso quel “realismo” (verismo per alcuni) che lo contraddistingue; ma l’uomo si confonde con gli oggetti, è cosa morta, puro pretesto grafico.
Nel brillante reportage di Libia, Camisa va oltre questi limiti, diviene maggiormente spigliato e aderente alle situazioni che gli si presentano, pur rimanendo assolutamente coerente a quell’asprezza espressionistica che è tipica della sua personalità. Ancora troviamo in lui il “disegnatore”, scrupolosamente preoccupato della figuratività dell’immagine (L’uomo dell’autorimessa, la bellissima Scuola coranica, ecc.) per un riscatto o una reazione alla irrazionalità e alla facilità della rappresentazione fotografica.
Con la sua recente produzione Gli uomini della confraternita e soprattutto Notte a Piedigrotta ci pare che egli stia dando il meglio della sua così complessa personalità e che sia riuscito a spogliarsi da ogni retorica di stile, da quella kafkiana visione delle cose umana come in certe sue immagini: La capra nel cimitero, Riposo, ecc., di una quasi macabra ironia.
Le immagini scattate a Piedigrotta ci appaiono come tra i più personali ed efficaci esempi di reportage fotografico; ogni frammento, ogni squillo di luce, tagliente come una lama a segnare volti e figure, reca la firma drammatica e inconfondibile di Alfredo Camisa.
The new reality in Italian Photography
(di Norman Hall, in «Photography», XIII, ottobre 1958, 10, pp. 32, 40, 67)
For those of us who are constantly on the look-out for new trends in photography, there is something exciting about recent development from Italy.
Here they have a new, young virile school of photographers who are instigating a nation-wide rediscovery of the true purpose of the still camera. In their own way, they are expressing themselves with a realism which has come to be accepted as a feature of the best Italian films.
At the same time, they are helping to clear away some misconceptions about the state of post-war Italian photography.
While there was an element of quiet charm about the first of the soft, high-key studies which came out of Italy in the early ‘fifties, these did not give the impression of having much to say. For a while, they were accepted as a step forward after a prolonged period of cultural repression. Here, it was thought, was an indication of willingness to experiment and better things to come.
Unfortunately, this hazy, shadowless technique ‘took on’ like an epidemic.
[…] What had started off as a sort of photographic gimmick was accepted by the exhibitionists as an end in itself, and in their enthusiasm they went on a long way towards discrediting still Italian photography in those days.
Fortunately, they were not wholly representative. There were others, working in their own way […]. The pictures they made were dramatic in their use of light and shade, stark in the simplicity of their directness.
[…] Two photographers who have been actively associated with this new movement are Alfredo Camisa and Piergiorgio Branzi. They convey their messages in the same bold, forthright style, a style which finds its expression mainly in the half-tones and which allows both highlights and deep shadows to go beyond the range of tonal gradation. Photographically, they speak with the same accent, but resemblance ends here – except that they have a common purpose in saying precisely what they mean and imitating nobody.
These pictures shown here are a fairly representative selection. […] With Camisa you will find a strong sense of design, a preference for the impressionistic rather than the record approach, a curiosity about the unreality which lies lurking somewhere behind every situation of reality.
I have asked each of them for a personal statement about themselves and about their attitude towards their art.
Alfredo Camisa writes: «I have been taking pictures for a few years but my interest in photography goes back a long time before I bought my first camera. Good examples of photo-reportage, like the Spanish Village story by Eugene Smith, influenced me tremendously. Also, I think the Italian movies of this period struck my imagination.
In the beginning my work was more graphic, with compositions which were more obviously contrived. I tried to find the hidden details of nature and to reveal some of the underlying aspects of reality. With my next step, I developed an interest in man and his environment. Man came into my photographic world primarily as accessory for my compositions. His purpose was more related to details of the world around him and he was not a centre of interest in himself.
Through various experiences I have gradually tended towards my present attitude of a desire for realism. Now I try to photograph man in association with his immediate environment.
I feel a strong interest and a sympathy for the man, for his happiness and sorrow, in his spontaneous reactions to the stimuli of his surroundings. Sometimes, these surroundings are such that they prove too much to endure.
There has been a tendency to condemn my sort of work as mere research into poverty and misery, but I feel that this misses my purpose. For me the most sincere expression of humanity itself is openly visible and not confused or distorted by the gadgets and conventions of what I called civilization.
I prefer not to get too involved with the technical aspects. Too much preoccupation with such problems as grain, resolution or camera movement can upset one’s judgment. Sometimes these so-called technical imperfections actually help to create atmosphere.
I do not believe that photographs are things to be framed and hung on walls. Photography goes further than exhibition – it is a recording of the history of our times and it must become part of the substance of our lives. I like to recall in this connection the verse by Carl Sandburg, from The Family of Man:
“There is only one man in the world
And his name is All Man”» […].
Photography year book 1960 “Star Photographer”. Alfredo Camisa.
In less than five years which have elapsed since he first bought a camera, Alfredo Camisa has exercised a distinct influence on the photography of his fellow-countrymen. With other young Italians he has helped to bring about a new movement. When it is remembered that he’s a non-professional and that his photography is a product of his spare time, the development he has made seems all the more remarkable.
At first he subscribed to the established Italian school of salons and exhibitions an […] it did not give him what he wanted from photography. He had to find this for himself and the result has been the growth of a distinctive style of working in which realism and stark simplicity, coupled with a strong sense of design, form the chief ingredients. […] About his work he writes «my ideas about realism are subjective and personal. I like to search for unusual characters or environments and it is largely because of this that the majority of my work has been done against the bizarre and highly emotional backgrounds of Africa, the south of Italy, Sicily, Spain and, more recently, in the world of the theatre. I search for the subjects which are strong in tones and I like to emphasize these tones when printing».
«This search for strength in the tones is not a passing whim. For me it has the precise function of a personal interpretation of the subject and in demanding this I am well aware that it robs my pictures of the essential character of true reportage. Recently, I have turned more to available light work – night scenes, interiors and theatre. It is a sort of work which has been made more easily practicable by the introduction of new hypersensitive films and, for Italy at least, it is a field which is rather new».
Camisa works no more for salons or exhibitions. He takes pictures to please himself and concentrates largely on making series on single subjects. His work is shown frequently in magazines and books, but, he says, «they are never news photos».
This is the fourth year in which Camisa’s pictures have appeared in «Photography year book» and it is a pleasure to “star” him on this occasion.
Alfredo Camisa e il teatro
(di Roberto Rognoni, ora in Alfredo Camisa. Autore dell’anno, Collana monografica FIAF, FIAF, Torino 2007, p. 108)
Sono sicuro che non molti sanno che Alfredo Camisa ha realizzato delle foto a teatro. Conosciuto per le indimenticabili immagini dei contadini del sud, nelle quali la luce solare è elemento determinante, è difficile pensare che Camisa possa essersi cimentato, con risultati egualmente apprezzabili, con un soggetto in cui la luce è debole, in alcuni casi al limite della riproducibilità fotografica.
[…] Queste immagini sono state prodotte nel corso degli anni Cinquanta al Piccolo Teatro di Milano, il mitico tempio del teatro italiano, reso famoso in tutto il mondo da Paolo Grassi e Giorgio Strehler.
Le sue non sono immagini di teatro, cioè della scena, dello spettacolo, ma foto a teatro, realizzate dietro le quinte, in genere prima degli spettacolo, con l’intento primario di fermare la tensione degli attori, la preparazione nei camerini, la stanchezza delle lunghe attese e delle prove. Un’analisi quindi personale del teatro, rivolta ai suoi personaggi, volutamente non tenendo conto degli elementi che sono peculiari della fotografia di teatro: l’espressione e il gesto dell’attore, la composizione coreografica, la tensione del movimento, l’organizzazione dello spazio scenico, degli arredi e delle luci.
[…] Quindi quella di Camisa è un’interpretazione assolutamente soggettiva dell’ambiente teatrale, senza alcun riferimento diretto alla scena.
Queste fotografie sono comunque importanti per il teatro, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto ambientale e “storico”. In un breve periodo di tempo è riuscito a immortalare personaggi che oggi fanno parte della storia del teatro italiano: Paola Borboni, Tino Buazzelli, Valentina Cortese, Ottavio Fanfani, Franco Graziosi, Milly e Marcello Moretti il primo Arlecchino di Giorgio Strehler. Per finire una Franca Rame nello splendore della giovinezza, che al tempo faceva piccoli spettacoli delle avanguardie intellettuali negli intervalli di attesa delle grandi rappresentazioni “strehleriane”.
Alfredo Camisa con queste foto non smentisce il suo stile linguistico, sempre attento a cogliere i sentimenti dei suoi soggetti, con una rappresentazione formale di grandissima efficacia.
Qui allude a El neorealismo en la fotografia italiana.


La fotografia in Italia. 1945-1975
Duecentocinquanta capolavori firmati dai maggiori autori italiani offrono al visitatore un percorso di scoperta e di conoscenza dell' Italia dal dopoguerra agli anni della contestazione e delle tensioni sociali...

Alfredo Camisa, Autore dell’anno
Per la collezione Autore Dell'Anno della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) il volume di quest'anno è dedicato a Alfredo Camisa, figura di grande importanza del mondo fotografico italiano